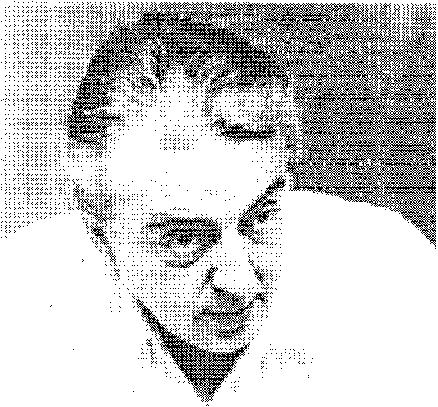
INDICE
Per ricordare Michele Risso
Introduzione
Lettera a Renzo Vespignani
«Nuova psichiatria. Attenti a chi parla di crisi
Farfalle, uomini e topi. Cioè: a ciascuno il suo farmaco, naturalmente
La Psichiatria dopo l’abolizione dei manicomi
Psicanalisi e consumo: metapsicologia e metastoria
Cronicità e cronificazione
Sulla formazione degli operatori psichiatrici
Da Ernesto De Martino a Michele Risso.
Nota su Sortilegio e delirio di Risso e Böker
Sortilegio e delirio. Appendice 2
A mezza parete
Terapeuta e politico, psicoanalista e antipsichiatra,
Michele Risso, compagno di Basaglia nella contraddizione
Cosa ci ha insegnato Michele Risso.
Abbattere i muri del silenzio, ecco il mestiere di vivere
Bibliografia provvisoria di Michele Risso
(a cura di Paolo Tranchina e Maria Pia Teodori)
Quaderni C.I.P.E.C.
Attività
PER RICORDARE MICHELE RISSO
“…la psicanalisi non può candidarsi come ancora di salvezza, come sostituzione di ciò che non è avvenuto nel sociale, né come pratica di reintegrazione degli individui all'interno di quella stessa logica che li ha tenuti lontani come persone prive di destino. L'analisi non è la salvezza perché, in tal caso si costituirebbe, come tutte le salvezze, come luogo catechistico di liberazione, come promessa la cui realizzazione è legata al perpetuarsi di una fede. Essa deve continuare a porsi come processo critico e contraddittorio vissuto nell'ambito di una relazione duale all'interno della quale è possibile la ricerca di un nuovo modo di relazionarsi agli altri…”
(Michele Risso)
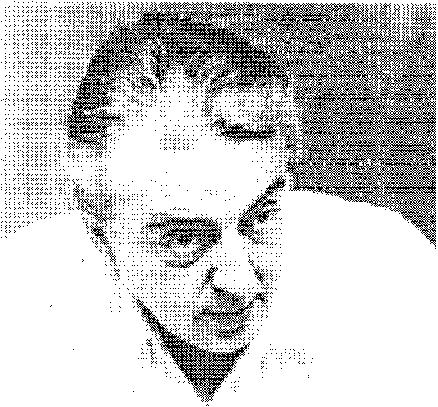
INTRODUZIONE
Il lontano venerdì 1 marzo si è svolto a Boves il convegno Per ricordare Michele Risso, primo incontro per ricordare il grande psichiatra a Boves nato e vissuto per parte della sua vita (giovinezza e studi).
La figura era purtroppo quasi ignota in paese e per la scarsa familiarità con le tematiche su cui aveva lavorato e per la netta scelta “di parte” che aveva compiuto nella sua stessa professione (è tra i fondatori di Psichiatria democratica) e per le scelte politiche (la militanza politico- culturale di sinistra) molto lontana dalla più parte dei bovesani.
Il convegno con interventi del sindaco Pellegrino, di Agostino Pirella e con lettura di una lunga comunicazione di Franca Ongaro Basaglia, assente per malattia, serviva a spezzare, almeno momentaneamente, il silenzio sulla personalità di Risso e sui grandi temi da lui e altri/e sollevati.
Seguiva la pubblicazione degli atti dello stesso, comprendenti le relazioni, gli interventi nel dibattito e alcuni contributi scritti (Gianna Tangolo, Regina Chiecchio, il mio, e una splendida lettera di Pietro Ingrao, amico personale di Risso).
A distanza di dieci anni, ancora il comune di Boves, la scuola di pace e il CIPEC hanno organizzato un secondo convegno, questa volta articolato su due serate, per ricordare il venticinquesimo anniversario della morte, purtroppo tanto prematura. Il titolo, con forte richiamo pavesiano Abbattere i muri del silenzio, ecco il mestiere di vivere, riprendeva il commosso saluto di Ingrao sull’ “Unità” del 5 giugno 1981, in occasione della scomparsa di Risso. Nell’occasione del secondo convegno, per gli smemorati e i giovani abbiamo ristampato il vecchio quaderno, la cui rilettura ce lo ha fatto sembrare ancora attuale.
Non buona (segno dei tempi?) la partecipazione, ma ricco e stimolante il dibattito.
Sono intervenuti Paolo Tranchina, direttore di Fogli di informazione, organo di Psichiatria democratica, Fabrizio Ciappi, Maria Pia Teodori, Domenico Casagrande, Luciano Sorrentino, Silvana Cottino, Antonio De Salvia.
Il ricordo del grande psichiatra nel clima culturale degli anni ’60 - ’70 si è legato alle attuali proposte di Psichiatria democratica e all’analisi di tematiche (carcere, migrazione, esclusione) nelle difficoltà dell’oggi.
E’ sembrato opportuno, a distanza di alcuni mesi, proporre un nuovo quaderno che contenesse alcuni scritti di e su Risso (parte curata da Gianna Tangolo) e un abbozzo di bibliografia, elaborata da Paolo Tranchina e Maria Pia Teodori.
Ricordiamo ancora alcune note sintetiche della biografia dello psichiatra bovesano.
Nasce nel 1927, studia medicina a Torino e quindi si specializza in neurologia e psichiatria. Dal 1955 al 1963 lavora come psichiatra a Berna dove compie una indagine sugli italiani ricoverati negli ospedali psichiatrici tra il 1946 e il 1960. La migrazione - scriverà con Delia Frigessi Castelnuovo in A mezza parete (Torino, Einaudi, 1961) - produce sradicamento, nostalgia come malattia, malattia mentale. E’ inutile ricordare quanto il tema sia attuale oggi.
Nel 1963 rientra in Italia, lavora a Roma come psicanalista e partecipa alla grande stagione che dà vita all’esperienza di Psichiatria democratica.
Il lavoro condotto da Franco Basaglia e dalla moglie Franca Ongaro negli ospedali psichiatrici di Gorizia e Trieste è alla base del lavoro dell’associazione. I capisaldi sono la contestazione dell’istituzione manicomiale, il rifiuto dell’elettroshock, il drastico taglio degli psicofarmaci, la nuova concezione della malattia mentale intesa come patologia sociale che si può curare all’interno della società e non in istituzioni escludenti.
Risso, un po’ atipico nel gruppo dei fondatori dell’associazione per l’attenzione alla pratica psicoanalitica, collabora attivamente al dibattito e all’azione che porteranno ad approvare la legge 180 che pone l’Italia all’avanguardia fra tutti i paesi del mondo (si veda il suo contributo al testo, curato da Basaglia Che cos’è la psichiatria?, Torino, Einaudi, 1973).
Come per altri protagonisti del movimento, primo fra tutti il suo fondatore, la morte lo coglie giovanissimo, a Roma, nel 1981.
Ci auguriamo che questo quaderno, contenente scritti, ancora così vivi e colmi di passione, serva non solamente a far pensare alla figura dell’autore, ma a riconsiderare l’attualità di una tematica e di una pratica che la restaurazione, iniziata negli anni ’80 e certo non terminata, tende a misconoscere, a cancellare, riproponendo vecchie certezze che grandi figure come Basaglia, Risso, Pirella, in un clima culturale e politico diverso e all’interno di una forte spinta democratica di massa, avevano messo in discussione e superato.
Sergio Dalmasso.
LETTERA A RENZO VESPIGNANI
(Impressit - bimestrale di grafica contemporanea; Vol 1, n. 3-4; settembre-novembre 1971- Editore IL GRAFO)
Michele Risso.
Lo scritto dello psicanalista Michele Risso, che pubblichiamo di seguito, potrebbe apparire decentrato rispetto all'area d’intervento di Impressit e da un punto di vista rigoroso lo è. Ma, pure imperniata su problemi concernenti il settore sempre più articolato della grafica, Impressit è aperta al mondo dell'arte nel suo complesso. L'articolo di Risso si raccomanda inoltre per il suo taglio insolito, e perché indaga da un osservatorio tutto particolare l'arte di uno degli artisti più penetranti - ed uno dei maggiori grafici - dell'arte italiana di oggi.
Me la pietra commuove Che la vita non tocca
(da un poeta anonimo)
Caro Renzo,
I critici d'arte - a mio avviso - sono costretti ad un lavoro ingrato: dire «chi è» e «di che cosa si tratta». Non li invidio. Io non sono un critico, né sono competente di arte. Parlare della tua pittura mi sarà impossibile: andrà bene se riuscirò a parlare con te attraverso la tua pittura. Ma finirà che parlerò di me. E ti dirò quello che io penso, non quello che per me sono i tuoi quadri.
Il rapporto io-immagine è un colloquio interiore, con le risonanze che in me provoca la vista di ciò che è stato detto. Io, spettatore, non "capisco" nulla, ma posso iniziare un dialogo con me stesso, scoprendo ancora una volta ciò che mi attrae, mi entusiasma, mi respinge, mi spaventa.
Una continua proiezione di me sulla tela ed una continua riflessione della tela su di me. Una immagine tu te la porti dentro, come poesia, musica, insulto, stridore: e il dialogo continua. Guardare un quadro - vederlo, non solo guardarlo intenzionalmente - significa soprattutto comprendere. Prendere l’immagine con sé. Un mio amico mi raccontava che, guardando una donna, le disse: « .. .ferma, così, con le mani intrecciate, così sembri la Gioconda! ». Aveva visto il quadro infinite volte. Ora, la Gioconda, non ha le mani intrecciate. Ma la sua (quella del mio amico) si.
La pittura è continuo sottinteso, spesso diventa frainteso, anche più spesso si reifica come malinteso, cioè come giudizio. Ma come tale può essere ufficialmente accettata perché riduce un significato - meglio, un significante - a pura cosa. È più facile apprendere che comprendere, è più comodo. Ci si divide il lavoro. Tu fai il quadro, egli lo giudica, noi leggiamo, voi discutete, essi comprano. Finito, prossima mostra.
Io vorrei evitare malintesi, o, almeno, chiarire di quali malintesi si tratta: parlerò di me, cercando di parlare con te di noi. I tuoi disegni i tuoi quadri mi attirano, mi stupiscono, mi mettono a disagio e mi irritano: rispecchiano quel rapporto conflittuale che ho, appunto, con me stesso. Passo, infatti, da un sentimento pieno di corposa sicurezza che sa tuttavia di colpa, ad un sentimento di assoluta friabile precarietà; quest’ultimo, accompagnato dalla soddisfazione di essere così bravo da avere capito che ne ho proprio tutte le ragioni. Sento la vita scorrere sotto la pelle, calda, irradiante; e la morte serpeggia armonica, tranquilla, esatta. Mi voglio bene nonostante questo o, forse, per questo, nonostante tutto (non prima di tutto: Narciso è morto, noi continuiamo a lavorare).
In genere lo senti a metà strada. Prima il dialogo interiore si struttura in termini di io-altro, dentro-fuori, qui-là, prima-dopo. Passato l'arco, la morte è tutta nostra. I termini sono sì e no, legati all'unica indissolubile radice. Prima si guarda con orrore la morte, fuori. Ma sono gli altri che muoiono, noi siamo ancora vivi. I campi sono nettamente separati o, almeno, crediamo che sia così. Lo storpio appoggiato alle stampelle, con l'umiliante berretto militare, è ribellione, rabbia, dolore, pietà. Si tratta, però, della sua morte - morirà prima di noi - non della nostra. La nostra la si assume, meglio, la si scopre dentro, col tempo.
Mi sembra che tutto ciò segni il percorso della tua pittura. E’ sempre una denuncia, una accusa, prima del mondo esterno, poi di ciò che scopri vivere dentro di te. Non vorrei essere frainteso. La violenza, la brutalità, la distruzione sono fatti reali e tremendi: ma sono anche schermi per la inconscia proiezione di ciò che noi abbiamo dentro. Suscitano orrore ma, paradossalmente, possono rassicurare: non siamo noi, non siamo stati noi, non siamo vittime né aguzzini. Una proiezione, prima, una riflessione, poi. Non ci sono compiacimenti masochistici né sapienti autotorture (come altri, a mio avviso, sbrigativamente, sostengono). C'è la stessa passione di prima: la pietà, l'orrore, la ribellione sono le stesse. L'accusa e la denuncia continuano, ma sono rivolte ad una condizione e non - o non soltanto - ad una realtà esterna. Il passaggio dal «fuori» al «dentro» si sente, si vede. La carcassa dell'animale vivo di gonfia putrefazione conduce alla metamorfosi kafkiana: «e la vera metamorfosi non è uomo-insetto ma uomo che lotta - uomo che subisce, uomo vivo malgrado la morte - uomo morto nella vita apparente»1.
Sono d'accordo, a patto che si cancelli la parola "apparente". Quindi, un uomo vivo, malgrado la morte nella vita. Col tempo raggiungiamo in noi stessi maggiore chiarezza di questa contraddizione e della necessità di viverla con una continua ricerca e scelta. Ma la fondamentale contraddizione è fatalmente espressa con una ideologia dietro la quale vibra la nostra ambivalenza: ideologia che, dall’esterno, viene ascoltata, letta, guardata, interpretata in chiave di inevitabile ambiguità. Perché li problema sì-no deve pure esprimersi su coordinate di spazio e di tempo, in termini di io-altro, dentro-fuori, prima-dopo, qui-là.
Non si ragiona più in questi termini nel nostro dialogo interiore, tuttavia siamo costretti a servircene per tentare di comunicare attraverso essi. A questo punto, il lavoro diventa terribilmente difficile e può lasciare insoddisfatto e disperato chi lo fa e scontento chi lo guarda (chi lo compra no, quello investe: viviamo un mondo di continui omicidi investimenti).
Il problema si presenta ora nella veste di una morte che deve essere esaminata, consumata sempre più a fondo e così affannosamente esorcizzata; e di una vita minacciata che deve essere «fissata» nell'eternità dell'attimo.
Nelle tue affannose dissezioni contro il tempo, tu ti trattieni a stento dal giungere subito all'osso, ché almeno quello tiene, non si deteriora più ed è - opportunamente trattato - cosi bianco, asciutto, essenziale, pura forma da essere accettabile quale emblema di eternità (molti, in sala settoria, non toccherebbero un cadavere, ma prendono in mano con naturalezza – con gioia direi - un teschio ben pulito). Gli studi sui vivi, i ritratti sono una paziente frenesia invasa da perfetto sgomento: come partorire in campo aperto sotto una pioggia di bombe, e non si sa mai se sia troppo presto o troppo tardi. Devono essere così come sono, immediati, esatti: l'attimo e tutti gli attimi che seguiranno fino all'Essenza, alla Vera Forma al Fossile. In movimento eternamente statico.
Ecco, c'è un attimo in cui ci sono tutte e due, nell'unità di tempo: vita e morte. Ma non dura. II verdolino, il viola pallido, il rosa-giallo, il sangue diviso, corpuscoli da una parte, plasma dall’altra si snodano con voluttuosa distruttività ed invadono l'immagine fissata con disperazione. Siamo perduti. Allontanarsi velocissimamente dal quadro e guardare. Ma è evidente, si tratta di fantasmi, esseri che ci sono, sì, ma non ci sono, non ci sono più, ma ci sono ancora. La eroica ibernazione è riuscita: il quadro appare ghiacciato, limpido, asettico; i veli si gonfiano, i visi si librano privi di peso e pure fermi, marmorei, eterni. I tuoi amici dell'Imbarco per Citera mi appaiono (in particolare i pittori della Vocazione) come monumentali ectoplasmi in formalina. Fermissimi e tuttavia galleggianti a mezz'acqua.
Che non si salvi proprio nessuno? Direi, a questo punto, che tu decidi di sacrificare l'Uomo e di salvare la Donna. Per l'uomo non c'è futuro vivente, ma iterativa ricerca. Solo la donna crea. Qualcuno da salvare dalla minaccia e qualcuno che ti salvi. All'atto dell’Imbarco, è l'uomo che va verso la perdita di sé. Va, soprattutto, verso un futuro che appare inaccettabile e vuole liberarsi di un passato inaccettabile.
II mondo che ci vediamo costretti a distruggere - perché non ci distrugga - è anche quello che vorremmo salvare, non perché sia da salvare, ma perché è nostro, come la nostra storia che non possiamo negare. Ma tra i poli di questa ambivalenza, la fiera Netta-Giuditta trascina veramente un trofeo mozzato o porta via, a viva forza, colui che vorrebbe imbarcarsi? La Donna mutila e salva nello stesso istante. Io dentro mia madre. La fuga - rifugio in avanti verso la scadenza che, puntuale, esatta, ma ignota, deve essere affrettata - è espressione di fuga all'indietro nel non-tempo e sbocca nella contemplazione di una realtà in cui il palpitante desiderio di appartenere e la dolorosa coscienza di essere esclusi sono intensamente presenti: Netta in attesa di Marta. La donna ha – sola – il privilegio di attendere la vita. A te, ad Alessandro, all'uomo non rimane che il trionfo coronato di carta dorata e simboleggiato da spade di plastica.
Una presa di coscienza, d'altra parte non è fissità o stasi, ma evoluzione e dinamica. Non è il trionfo che intimorisce, ché la ricerca continua e non importa se lo si ritrova per strada. Siamo perdenti in ogni attimo della esistenza ed è appunto per questo che continuiamo a lottare. Nel dubbio, nella inevitabile ambiguità: guardare sotto le pietre non vuol dire sempre ribaltarle (poterle, volerle ribaltare, tutte). Ma questo è un discorso che riguarda me e che io faccio a te. Tu e la tua pittura la penserete in un modo magari del tutto diverso. D'altra parte, l'ho detto all'inizio che avrei parlato me. Vedrai: diranno che sono un Narciso.
Affettuosi saluti dal tuo
Michele
« NUOVA » PSICHIATRIA. ATTENTI A PARLARE DI CRISI
(L'Astrolabio quindicinale, n. 15, 14 agosto 1978)
a cura di Giorgio Bartolomei.
Il dibattito politico all'interno della «nuova» psichiatria italiana si trova oggi in un momento di impasse di natura sia teorica che pratica. Molti sostengono che si tratta di una vera e propria crisi. A dieci anni dalla «Istituzione negata» e soprattutto dal Congresso di Psichiatria Democratica del settembre '76 ad Arezzo in poi, come si caratterizza, secondo voi, la situazione attuale del movimento?
Adriano Ossicini: Io penso che bisogna stare attenti a parlare di crisi: bisogna vedere il punto di partenza, ossia in sostanza la nuova psichiatria si è sviluppata in una situazione drammaticamente difficile della psichiatria ufficiale.
L'ambiente ufficiale della psichiatria era in condizioni drammatiche, e per ragioni di strutture e per ragioni di cultura, esisteva in sostanza lo staff egemonico dei direttori di manicomi, dei direttori di cliniche, di psichiatri ufficiali in Italia, i quali erano, per ragioni di formazione di tipo culturale e come tipo di formazione professionale in un arretrato pauroso, anche più di quello che era la psichiatria di tipo ufficiale, non psicodinamica di altri paesi.
Anche la nuova psichiatria sconta un eccesso di rottura ossia l'eccesso di forza che ha dovuto utilizzare, non tanto contro l'ambiente socio-politico, che forse era abbastanza pronto, quanto contro le strutture che hanno una difesa prima furibonda e poi elastica, cioè mistificatoria; hanno fatto finta di accettare, accettando solo gli elementi formali di questo tipo di battaglia per invischiarla poi nelle panne quotidiane del sabotaggio.
Non c'è dubbio che oggi noi assistiamo ad una seconda fase che è quella che non è più di rottura ma di egemonizzazione, la quale ha i riflussi in tutte le rivoluzioni. Nessuna rivoluzione, anche quella politica, non ha dei reflussi quando deve passare da una fase di rottura ad una fase di egemonizzazione, ma in questo caso, a mio modesto avviso, le difficoltà sono duplici: una è quella che è consecutiva ad ogni rivoluzione, ad ogni rottura, ad ogni posizione di carattere avanzato che deve essere stabilizzata; seconda difficoltà, è l'enorme potere che hanno ancora le vecchie culture psichiatriche organicistiche e cosi via. Per questo favorite dal fatto che purtroppo la nuova psichiatria non ha potuto ampiamente utilizzare proprio quell’arma che era, secondo me, fondamentale per la polemica culturale con la vecchia psichiatria, che era la psicodinamica, ossia una delle difficoltà è stata ovviamente che nella battaglia in quel momento gli aspetti psicodinamici sono stati utilizzati ma non egemonizzati, non analizzati, ed una parte del residuo di una certa polemica vecchia contro la psicologia dinamica è stata ripresa in modo paradosso da certi ambienti politici e culturali che invece appoggiavano la nuova psichiatria. Questa è stata la contraddizione che purtroppo si sconta.
Michele Risso: Ossicini ha descritto un aspetto importante del problema. Vorrei aggiungere che, se noi teniamo conto dei messaggi iniziali della nuova psichiatria italiana vediamo che si tratta di messaggi essenzialmente politici.
Essi non sono stati recepiti come tali, ma tradotti e ridotti a proposte tecniche attraverso un malinteso, o, peggio una mistificazione avente come base la malafede di chi riceveva un messaggio che avrebbe messo in discussione tutto il significato dell'operare psichiatrico tradizionale. In altre parole, la battaglia iniziata a Gorizia nella prima metà degli anni '60 contro il manicomio aveva significati e mete politici: la psichiatria ufficiale non volle vedervi altro che indicazioni tecniche di miglioramenti riformistici; si disse che a Gorizia si era costituita una «comunità terapeutica» sul modello di precedenti esperienze anglosassoni.
È vero che si era formata allora una comunità terapeutica, ma ciò che di nuovo si era scoperto a Gorizia era in realtà il problema della emarginazione del malato di mente, curato nella apparenza, custodito nella sostanza, enucleato dalla storia e avulso dalla società. Verità dimostrata, col tempo, per tutti gli emarginati sociali, vittime di una logica che aveva - ed ha - tutto l'interesse a convogliare ogni tipo di devianza verso la medicalizzazione o verso la criminalizzazione.
Verissimo quanto dice Ossicini sulla rottura con la vischiosità ideologica della psichiatria ufficiale italiana che era - ed è ancora oggi in parte - di stampo neurologico e lombrosiano. La lotta è stata quindi lunga e dura ed è passata attraverso una pratica estenuante di un lavoro quotidiano che si opponeva come invenzione e significato alla ripetitività rituale tipica dei vecchi manicomi. Ci siamo serviti, nel comunicare la nostra esperienza, di mezzi che potessero rendere la pratica e la tendenza dell'operare intelligibili, immediatamente: ciò non ha portato a formulazioni teoriche trasmissibili e articolate per ciò che riguarda lo specifico psichiatrico, dato che la pratica del lavoro che avveniva, sì, nello specifico, aveva rilevanza soprattutto politica. Da parte di non pochi operatori provenienti dalla psichiatria tradizionale c'era una richiesta sul come si fa ad aprire, a liberare un ospedale psichiatrico; la nostra risposta riguardava sempre e soltanto, il cosa vuol dire aprire e liberare un manicomio.
Vorrei, se possibile, una precisazione da Ossicini che ha parlato di psicodinamica ed ha introdotto il concetto di psicoterapia come alternativa alla pratica psichiatrica tradizionale o di vecchio stampo. Il problema è importante e dobbiamo evitare malintesi.
Ossicini: Non c'è dubbio che se tu vai a leggere non solo la storia delle esperienze iniziali molto importanti dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista culturale, tu vedi che in sostanza vengono usate di fatto una serie di modalità di intervento che sono psicoterapiche. Usavo il termine psicodinamica per dire quale era la parte teoretica che stava dietro questo aspetto psicoterapico, perché in sostanza psicoterapico è tutto, anche la terapia dell'elettroshock è una terapia della psiche, anche la psicofarmacologia è una terapia delle psiche, il termine psicoterapico è usato in modo molto generico. In un rapporto di apertura dei manicomi, di apertura delle istituzioni, se si è trattato il malato, con il malato ogni trattamento, ogni tipo di dialogo è stato psicoterapico. Si tratta di vedere come! Nell'aprire i manicomi, nel fare uscire la gente dalle istituzioni e così via, questa gente è stato necessario trattarla, occuparsene, parlarci, in gruppo e personalmente. Allora si sono usate di fatto delle tecniche psicologiche, spesso non si sono qualificate, non si sono quantificate, e si sono addirittura negate, questa è una delle cause di crisi. Se la psicoterapia si deve fare, essa va inquadrata nel grande movimento della psicologia moderna, che chiamiamo in qualche modo psicologia dinamica; potremmo vedere poi di quale scuola di quale orientamento.
Risso: Va bene, d'accordo, non c'è approccio al malato che non comporti l'impiego di una tecnica. Negarlo sarebbe assurdo, come sarebbe assurdo negare che due esseri umani, parlando insieme, stabiliscano rapporti di comunicazione. Altrettanto chiaro è che l'operatore non agisce a caso con l'utente (pessimo termine quest’ultimo per indicare una persona in una condizione di sofferenza), ma ha in testa un modello di salute/malattia cui volente o nolente deve fare riferimento: e si comporta quindi di conseguenza. In altri termini, l'operatore vuole un risultato del suo operare, ha una strategia, una tattica: e si serve inevitabilmente di strumenti tecnici, codificati, dogmatici o critici che siano per realizzare un progetto di cura. Detto questo, parliamo però di un pericolo, e cioè della sostituzione acritica di una vecchia tecnica con una nuova, nell'ambito della logica delle ideologie di ricambio. Dobbiamo tenere conto di questo, dato che, lo sappiamo tutti, in psichiatria terapia e controllo sociale sono fattori intimamente connessi e difficilmente districabili.
Il pericolo del ricambio di una tecnica «vecchia» con una tecnica «nuova» è tutt’altro che trascurabile. Non è certo che, cambiando il colore della divisa di una guarnigione di una città o cambiando lo stile di marcia dei soldati, si modifichino i meccanismi di difesa o di oppressione dei cittadini. Il problema non è quindi quello di dare risposte nuove a domande vecchie, ma quello di porre domande nuove.
Inoltre, il ricambio acritico dei tecnici propone il pericolo della trasmissione verticale e acritica delle tecniche. Il problema non si pone, per me, in termini di tecniche, ma in termini di conoscenze. Credo che abbiamo il dovere, come operatori, di appropriarci di conoscenze relative al fondamento epistemologico, alla storia, allo sviluppo di quelle discipline che trovano poi applicazioni pratiche nel campo specifico della psichiatria e della psicoterapia.
Voglio dire che noi possiamo usare o non usare certe tecniche, possiamo rif1utarle, possiamo tentare di servircene come modelli di riferimento lavorando con spirito critico: ma dobbiamo essere in possesso di quelle conoscenze che precedono l'uso più o meno critico di una tecnica. Mi pare che su questo non ci siano dubbi, è un dovere al quale non ci possiamo sottrarre. Sottraendoci a questo dovere, rifiutando di essere istanze critiche nella inevitabile contraddizione dell'operare, noi rischiamo di favorire il «cambio della guardia» e la riproposta di sistemi di controllo contrabbandati come meccanismi moderni di terapia.
Ossicini: Non c'è dubbio che noi siamo contrari all'elettroshock, come siamo contrari alla psicofarmacologia di un certo tipo, come siamo contrari agli strumenti che strutturavano la vecchia psichiatria o organicistica, o idealistica, o positivistica. Non c'e dubbio che la meccanica e acritica sostituzione di queste tecniche, che comunque vanno sostituite, con le tecniche della psicoanalisi può essere una operazione ideologica. Dobbiamo tener presente però che bisogna stare anche attenti a non impazzire in un circolo vizioso, perché nulla è totalmente non ideologico. La possibilità di fare una operazione che non rientri in nessun modo in esperienze ideologiche significherebbe avere una società senza classi egemoni e senza posizioni totalizzanti di una classe o dell'altra. Noi dobbiamo arrivare ad un processo di de-ideologicizzazione, cioè di non formulazione ideologica rigida, meccanica. Non è possibile però illudersi che certi strumenti possono essere nella loro naturalezza avulsi da ogni inquinamento ideologico; è come parlare della scienza con la S maiuscola fuori della storia. Questo non ci deve far cadere però nel meccanico atteggiamento mentale che per questo non possiamo usare delle tecniche, ma allora la tecnica diventiamo noi ed è appunto un «delirio di onnipotenza». E’ chiaro che il valore del tecnico è quello di vedere, nell’esperimentazione, in che limite certe tecniche riescono a non essere influenzate in modi determinanti da un certo fatto ideologico. Se noi aspettiamo una tecnica che sia tutta fuori dell'ideologia, non avremo mai nessuna tecnica, ossia avremo di fatto delle tecniche mistificate che useremo non chiamandole tecniche. Il tecnico che vive la sua tecnica in una più ampia realtà politica può oltre che controllare sperimentalmente la tecnica valutarne i «limiti» ideologici.
Risso: No, non ci aspettiamo una tecnica fuori della ideologia. Sappiamo che non esiste nuovo messaggio nel campo delle scienze umane - e non soltanto in queste - che non venga subito immesso nella logica del potere che ha i suoi obiettivi, che vuole perseguire i suoi scopi. E’ chiaro che dobbiamo tenere conto di questo. Proprio a questo proposito, ho fatto cenno prima alla inevitabile contraddizione dell'operare, soprattutto nel campo della psichiatria dove cura e controllo sono indissolubilmente uniti. Voglio dire che non si tratta di cercare o volere una tecnica che non sia sottesa da una ideologia funzionale alla logica della norma e del controllo, ma di porre il problema in termini di cultura, prima che di tecnica.
Vorrei parlare brevemente di un problema molto grande che è quello della prevenzione delle malattie mentali. Ora, perché noi dobbiamo possedere delle conoscenze prima di servirci delle tecniche che da queste vengono derivate? Perché dobbiamo avere coscienza, da un lato, della precarietà del fondamento epistemologico delle tecniche che usiamo dall'altro che, nella testa della gente che si rivolge a noi, c'è la convinzione che noi ci stiamo servendo di un intervento causale per guarire. Cioè che quello che noi facciamo guarisce o può guarire la malattia. Il che, purtroppo, non è vero: ché noi non possiamo guarire una «malattia» definita sin ora sulla base delle più svariate ipotesi e non sulla base di fatti provati. In altre parole, noi sappiamo oggi che la malattia mentale è molto di più un prodotto che non un dato. Noi non curiamo una malattia nota, ma un grave disagio, una sofferenza via via tradotta in malattia dalle varie interpretazioni psichiatriche che ne sono state date nella storia della psichiatria, da un lato, e nella storia con i suoi condizionamenti sociali, economici, politici, dall'altro.
Voglio dire che, ogni volta che noi, con i nostri interventi tecnici, riconfermiamo nella mente degli assistiti l'immagine infondata che essi hanno della «malattia», facciamo un errore grave, ché ci opponiamo ad una vera opera di prevenzione del disturbo mentale. E’ quindi il nostro modo di atteggiarci come tecnici che permette la prevenzione o la impedisce. Ancora una volta, è la coscienza della inevitabile contraddittorietà del nostro operare nei confronti di un male sulle cui origini ben poco sappiamo; in più, usando tecniche che hanno fondatezza precaria, e con raggiunta di essere, al tempo stesso, interpreti della cura e aventi delega di funzionari del controllo. Tutto è contraddittorio e tanto più lo è in un periodo di transizione come questo. Le vecchie tecniche violente e di contenzione hanno rivelato tutta la loro barbarie ma una nuova scienza nel frattempo non è nata affatto. Continuiamo a servirci, ad esempio, di terminologie tratte dalla nosografia tradizionale, pur sapendo che la loro validità è scarsa e che la possibilità di riproporre con questi termini malintesi e distorsioni dell'informazione è molto grande. Dopo l'apertura e l'abolizione dei manicomi abbiamo visto che il decorso delle cosiddette schizofrenie non è quello descritto nei sacri testi, che queste malattie sono in parte prodotte e congelate nel loro esito spontaneo dalla reclusione asilare, dalla contenzione, dagli interventi di shock. E tuttavia continuiamo a parlare di schizofrenie, «per intenderci tra tecnici»: e mi pare che poco ci si intenda. Riassumendo: coscienza della propria contraddizione di operatori, necessità di appropriarci di una conoscenza che precede l'uso delle tecniche e che impone una critica continua del nostro operare come tecnici.
Come mai all'interno del movimento - a parte alcuni contributi - il problema delle «tecniche» non è stato oggetto di un dibattito ampio, ma ha rappresentato e continua a rappresentare un fantasma.
Risso: Il dibattito è emerso, in realtà, durante il convegno di Gorizia del 1974 ed è comparso ne «La pratica della follia ». C'è una relazione di Sergio Piro e mia su questo tema. Diciamo, appunto, che è necessario lo studio, che è necessaria la conoscenza, non ultima per potere discriminare tra le tecniche; scegliere, criticare, sbagliare, fare esperienze, in altre parole.
Bartolomei: Da Gorizia in poi, secondo me, nonostante alcuni tentativi il dibattito si è arenato. Anche nella intervista di Taverna difatti emergono delle posizioni molto difensive da parte di Basaglia e di Pirella rispetto a questo problema delle «tecniche», e in particolar modo nei confronti della psicoanalisi. Per esempio, riguardo al concetto di interpretazione, Basaglia afferma che «non c'è niente da interpretare», perché nel momento in cui si interpreta si ricade nella logica del potere del tecnico sull'utente-paziente, cioè viene riproposto il rapporto di potere.
Ossicini: Mi pare che il discorso di Risso sia molto chiaro. Noi stiamo in una contraddizione. Il problema è che lo psichiatra non si illuda o non si intimorisca pensando di essere l'unico professionista che è in una contraddizione. Chiunque lavora nella società è nella contraddizione tra tecnica e società. Non c'è dubbio che se noi siamo in qualche modo marxisticamente orientati e teniamo conto della dinamica della realtà sociale, non ci possiamo non rendere conto che in tutti i livelli della cultura l'importanza della dinamica sociale è determinante. Però, se noi vogliamo essere delle persone che poi hanno una funzione, dobbiamo renderci conto che tale contraddizione dobbiamo gestirla, non dobbiamo fuggirne. Ossia è molto grave dichiarare che la contraddizione non esiste perché è evidentemente l'atteggiamento della cultura borghese che nega questa contraddizione, ma è anche sbagliato l'atteggiamento che alla fine finisce per essere la stessa cosa, perché la fuga dalla contraddizione è la stessa cosa che la negazione. Ora il problema della interpretazione è questo: quando da me medico viene un malato di polmonite e interpreto i sintomi, è chiaro che uso un potere, ma se non interpreto i sintomi il malato muore. Ora, la psichiatria deve interpretare i sintomi e curare usando delle tecniche e perciò usa un certo potere, sennò cadiamo in posizioni idealiste. Noi dobbiamo gestire questa contraddizione, ma non gestirla genericamente, ma in modo specifico, chiaro che poi se saremo anche politicamente immersi nella realtà, valuteremo meglio l'elemento determinante e contraddittorio. L'essere psicologi o l'essere psichiatri significa quindi gestire delle tecniche, sapendo che le gestiamo in una situazione contraddittoria. Perciò, il nostro compito come tecnici è quello di interpretare, perché altrimenti se non interpretiamo non serviamo il malato.
Risso: Per quanto riguarda la psicanalisi è opinione di molte persone, anche psichiatri, che si tratti di un lavoro di interpretazione di contenuti. Non è certo cosi. La psicanalisi è interpretazione di un rapporto, è l'indagine della contraddizione di un rapporto, quello tra malato e terapeuta, rapporto che si propone in un «dentro» e che è espressione di un «fuori»; e con la ricerca di un rapporto di qualità alternativa che si opponga alla oppressione, alla distruzione dell'uomo. Certo, la psicanalisi non è soltanto questo: ma è questo - almeno per me - prima di tutto. E’ un atto terapeutico, ed è un atto legato al potere che tu eserciti: e bisogna esserne ben consci. Vorrei sapere a questo punto chi non esercita un potere sull'altro, sul paziente, in psichiatria, in psicoterapia. Non ci sono eccezioni a questa regola.
Ossicini: Si tratta di vedere in che condizioni, in che limiti gestisci un potere. Non possiamo giudicare le scelte e le culture su schemi di riferimento che ci fanno comodo e che sono vecchi. La psicoanalisi oggi non marcia più nelle vecchie strade di cent’anni fa. Per dirla con Fornari, anche se io non uso questo termine in modo rigido, noi siamo alla analisi coinemica non alla «Traumdeutung». La «Traumdeutung» è stata un elemento importante, i sogni ci interessano ma non siamo più miticamente legati ad una specie di vocabolario, di sillabario, in cui ci sono depositati dei simboli già interpretati e interpretabili, noi stabiliamo un rapporto, che poi è quello che è nella cultura moderna, perché se noi andiamo a vedere anche nelle altre discipline il problema dell'analisi del linguaggio, dello studio del linguaggio e non della negazione dei linguaggi, è fondamentale; dallo studio delle lingue fino allo studio della psicoanalisi i problemi del linguaggio sono determinanti nella cultura moderna. È chiaro, questa è un'epoca storica nella quale le scelte hanno avanzato in modo tale, sino alla filosofia della scienza, per cui impostano problemi di linguaggio; e la psicoanalisi li ha impostati prima con una certa rigidità storica nello «Zeitgeist» della cultura dell'epoca e man mano li ha modificati. È chiaro che noi oggi ci muoviamo in modo diverso. Il solo problema, per esempio, dell’analisi del transfert che è poi l'elemento fondamentale del nostro discorso, ci permette di valutare la cultura, la struttura, la natura, tutte queste cose in un rapporto che è di reciproca interazione. Il fatto che la psicoanalisi ha per prima chiamato il terapista a scendere dalla sua onnipotenza, analizzare prima se stesso e poi l'altro, ossia non fornirsi come strumento acritico, onnipotente e depositario di una verità, questa è la grande rivoluzione di Freud, che è il primo che ha detto quello che dice il marxismo, cioè che l'individuo non può essere misura delle cose acriticamente, perché altrimenti è misura nella sua delirante onnipotenza, ma deve cominciare a sottoporre se stesso ad un'analisi critica che poi gli permetta di analizzare l'altro. Allora: l'analisi del transfert, l'analisi del linguaggio, l'analisi del rapporto, ma secondo uno schema di riferimento che abbia una certa validità culturale e una certa operatività tecnica. Questo è il campo che mi pare giustamente premetteva Risso. Allora è chiaro che sarà difficile che la «nuova» psichiatria rapidamente possa riprendere il cammino, perché le battaglie che ha fatto sono grosse, ma la strada per riprendere il cammino è difficile: una strada non difensiva, ossia tutte le grandi rivoluzioni culturali hanno certamente dei momenti di crisi, se però una persona ha paura e si difende ha «chiuso»; cioè quali che siano i pericoli della psicodinamica, della psicoanalisi, l'unico modo per evitarli è affrontarli, se noi ci chiudiamo negando il dato reale che esiste un'interpretazione, di fatto la facciamo ma sfasciamo tutto. Per ciò, secondo me, il grande orizzonte che si apre alla nuova psichiatria è proprio quello di un discorso serio, culturale e tecnico, sulle basi della psichiatria, ossia sulla psicologia.
Risso: Rispondo brevemente alla domanda di Bartolomei sulle posizioni definite «difensive» di Basaglia e Pirella rispetto al problema delle tecniche. Psichiatri che hanno una pratica di lotta possono anche lasciare da parte problemi riguardanti l'impiego delle tecniche psicoterapeutiche. I problemi che questi psichiatri devono affrontare giornalmente nel lavoro antimanicomiale sono di portata pesante ed assorbono i loro interessi in campi ben lontani dalla applicazione delle psicoterapie. Quando ti trovi davanti centinaia di malati ridotti in una condizione di miseria individuale, sociale, economica; malati per i quali e con i quali puoi provvedere soltanto con enormi difficoltà e dispendio di energie; e sapendo che la permanenza del manicomio attira altri nuovi malati votati alla fine dei primi, credo che ti puoi permettere di dire che a questo punto della psicoterapia non te ne importa molto, che una tecnica vale l'altra e che nessuna vale fino a quando la distruzione sociale del malati è così evidente nel suo orrore. Questo non toglie tuttavia valore a quanto detto prima, sulla necessità di acquisire conoscenze specifiche nel campo della psicoterapia. La situazione nella quale l'operatore psichiatrico si troverà a lavorare in futuro sarà non più il manicomio ma il vivo del contesto sociale. Si proporrà il problema della formazione di operatori; e questa rischia di essere ancora una volta settoriale, priva di retroterra culturale; e proporrà ancora una volta la divisione del lavoro, delle «competenze», in sostanza di un potere che non andrà certo a vantaggio del malato; formazione che avrà, come risultato, l'uso acritico delle tecniche. Proprio quello che si vuole evitare.
A questo punto la nuova psichiatria non può limitarsi ad esprimere una critica. Mi sembra venuto il momento di formulare concrete proposte operative, se crediamo che il problema sia, appunto, quello di partecipare conoscenze e non di trasmettere regole per applicazioni tecniche.
FARFALLE, UOMINI E TOPI.
CIOÉ: A CIASCUNO IL SUO FARMACO, NATURALMENTE
(il manifesto, 19 settembre 1979)
di Michele Risso
Ricordo una vecchia storiella. Il padre vuole educare il figlio pubere alla vita sessuale. Gli dice: «Ricordi quella gita in montagna, tu ed io, soli, nella bufera? Ricordi come trovammo rifugio in quella baita dove c'erano, sole, madre e figlia? Tu giacesti allora, figlio mio, con la giovinetta, ed io con la di lei mamma. Ebbene, figliolo, le farfalle fanno la stessa cosa».
La storiella mi viene in mente, riferita a tutt’altro contesto, leggendo l'articolo - intervento di Gian Luigi Gessa, direttore dell'istituto di farmacologia dell'università di Cagliari, a proposito della ricerca biologica nelle malattie mentali (il manifesto, 31 agosto '79). L'autore, a sostegno della tesi, peraltro inoppugnabile, che il biologo può essere storicamente determinato e che il sociale può indurre modificazioni e danni biologici, dice: «Per esempio, se si pongono dei topi in condizioni di sovraffollamento, o di isolamento, si producono delle alterazioni neurochimiche, anche irreversibili, che producono un comportamento alterato e che i farmaci possono prevenire o «curare». Negli animali di laboratorio, perfino una dieta non equilibrata somministrata alla madre può indurre modificazioni irreversibili sulla composizione chimica del cervello dei figli, che si traducono in un comportamento alterato dell' adulto» (le sottolineature sono mie).
Si potrebbe dire che sembra poco opportuno fare esperimenti in laboratorio quando, per ciò che riguarda l'uomo, il sovraffollamento e l'isolamento sono sotto i nostri occhi, «in natura» (si fa per dire), nei ghetti urbani, nei vetusti manicomi, nelle carceri, negli ospizi, nella vita desolata degli emigrati, nella solitudine di molti vecchi e di molte casalinghe. Per quanto riguarda, poi, gli esperimenti con dieta non equilibrata, basta pensare alle plaghe depresse del terzo mondo, dove gli squilibri dietetici si chiamano fame cronica; e toccare con mano le radici storico-biologiche della qualità della vita di milioni di persone che vegetano sonnolente agonizzando ai limiti della sopravvivenza.
A questo punto, un assurdo suggerimento. Perché non esaminare sperimentalmente in laboratorio le condizioni neurochimiche, il substrato del comportamento di un topo che vive «libero», con la possibilità di entrare ed uscire a piacimento da una grande gabbia, cibo in abbondanza, vita sessuale soddisfacente, passeggiate tonificanti, lunghi sonni ristoratori. E un balconcino dal quale osserva gli altri topi in condizione sperimentale di sovraffollamento o di isolamento.
Ora, a prescindere dal substrato biochimico, chi vorrebbe modificare con farmaci opportuni il comportamento del topo in oggetto? In altre parole, non è il caso di far ballare i topi, basta aprire gli occhi e guardarsi intorno.
Ma Gessa mi dirà che sa benissimo tutte queste cose e che ne tiene ovviamente conto: a lui interessa, e ciò che scrive ne dà testimonianza, il comportamento alterato ed il substrato neurochimico di questo. Qui, a mio avviso, gli occhi bisogna tenerli aperti riguardo alle conseguenze degli esperimenti in animali da laboratorio, nei quali si riscontrano, in condizioni di stress (e qui non il passaggio dal sociale al biologico, ma il salto dalla realtà sociale alla ideologia biologica) modificazioni neurochimiche; modificazioni che producono un comportamento abnorme; comportamento che può essere «preventivamente» impedito o «curato» con farmaci opportuni. Fin qui nulla di male, siamo in laboratorio. Ma è tuttavia strano che in laboratorio si cerchino le radici storico-biologiche dello stress da sovraffollamento e da isolamento e si sperimentino prodotti chimici adatti per la «prevenzione» e la «terapia». Per impiegarli, poi, come, questi farmaci? Per i milioni di roditori che, nelle grandi città, vivono, è noto, in spazi esigui e inospitali (topaie) o isolati nelle piaghe deserte del sottosviluppo? Credo di no.
Non voglio dire con questo che gli psicobiologi intendano «curare» con farmaci chi vive oppresso per la mancanza di spazio o chi soffre per l'isolamento. Questo, però, succede, eccome. Perché, nella fattispecie, chi va dallo psichiatra non dice che è pigiato con gli altri; dice che è irritato, labile, insofferente; e la casalinga cinquantenne isolata o il vecchio pensionato solo non dicono «sono una donna che fa una vita senza senso, sono un vecchio che non serve più a nulla»; ma dicono «al mattino non mi va di alzarmi, tutto mi costa una immensa fatica, non riesco a concentrarmi su nulla, mi addormento come un sasso e mi sveglio nel bel mezzo della notte... ». Lo psichiatra potrà, ovviamente, porre delle domande, voler sapere come in realtà vivono queste persone, chiarire quali sono le radici dell'oppressione e dell'emarginazione. Dopodichè, più o meno convinto e costretto, prescriverà ansiolitici e antidepressivi. Nel talloncino di accompagnamento dei farmaci non sarà certo scritto che tali prodotti servono contro il sovraffollamento o l'isolamento, ma si elencheranno i sintomi sui quali le sostanze prescritte agiscono, ansia, irrequietezza, apatia: sintomi riscontrati negli animali da esperimento che presentano, appunto, alterazioni neurochimiche dovute allo stress descritto.
Abbiamo quindi scienziati che hanno dimostrato in laboratorio che il sociale incide sul biologico; ma abbiamo, al tempo stesso, un «substrato» biologico sperimentale che giustifica l'uso del farmaco. Farmaco che può essere usato, è vero, per lenire la sofferenza: ma che viene usato, in una stragrande maggioranza di casi, per occultarne le cause; comportamento storicamente determinato, così come è storicamente determinata l'oppressione e l'emarginazione delle persone malate, inutili, improduttive, in un mondo dove è proibito ammalarsi, pena la «terapia»; dove la sofferenza viene lenita, sì - e imbavagliata.
A ciascuno il suo, quindi, in questo mondo dove si sa tutto sul sintomo, salvo togliergli costantemente la parola.
A ciascuno il suo farmaco, naturalmente.
LA PSICHIATRIA DOPO L'ABOLIZIONE DEI MANICOMI
(MONDOPERAIO, n. 2, febbraio 1980)
Michele Risso e Giorgio Bignami
Per due secoli la psichiatria ha osservato il malato di mente dato che doveva custodirlo e lo ha custodito dato che doveva osservarlo. Reificato nella clausura, oggetto nudo dell'osservazione, il paziente è stato avviato a un «decorso» pre-scritto nei libri e nella mente dei medici. Non si poteva sfuggire a questa logica se non abbattendo i manicomi, sacche di deposito di «abnormi» indesiderabili, calamite di processi di biologizzazione del sociale. La psichiatria ha ora davanti a sé gravi scelte e gravi rischi, ma anche grandi possibilità, dati i minori condizionamenti rispetto a una medicina segnata da decenni di dequalificazione mutualistica e di elefantiasi ospedaliera. Seguendo una strada che eviti sia il riciclaggio tecnicistico delle terapie tradizionali sia le ideologie antiterapeutiche, si potrà giungere finalmente a dare un'assistenza civile ai sofferenti.
Il malato di mente (definizione discutibile, usata in assenza di migliori) è sempre stato considerato come se la sua condizione fosse riferibile ad uno stato che ne permettesse l'immediato riconoscimento. Data la sua misteriosa e contagiosa alterità egli è stato costretto o in una diversità investita di potere (lo sciamano, il profeta) o in una diversità esecrabile (la strega, il vagabondo, il pericoloso delinquente) .
Da poco meno di due secoli, questo malato è entrato a far parte dell'immenso campo di ricerca e di applicazione della medicina, uscendo al tempo stesso dallo spazio della interazione psicosociale. L'ultima operazione traduttiva da condizione a stato ha coinciso con l'istituzione dei manicomi, luoghi dove si è fusa l'alleanza fra morale e biologia, simbiosi di un approccio punitivo rivolto alla pericolosità-colpa e di un approccio fatalistico-naturalistico rivolto ad una «lesione» cerebrale sempre ricercata e sempre da dimostrare. Per due secoli la psichiatria ha «osservato» il malato di mente dato che doveva custodirlo e lo ha custodito dato che lo doveva osservare: ed ha trovato conferma di inconsistenti ipotesi che nel carcere manicomiale si sono sedimentate come fatti; per giungere, a mezzo cammino, alla definizione di un paziente incurabile, demente precoce, schizofrenico, ovvero irreversibilmente costretto nella spirale maniaco-depressiva. Da un secolo si parla di malattie mentali come se si trattasse di qualcosa di definito nella loro origine. In realtà nessuno è stato in grado di dare, di questi fenomeni, una definizione fondata e attendibile, sia da un punto di vista biologico che psicologico o sociologico.
La malattia psichiatrica
Sino ad oggi la maggior parte degli psichiatri ha riconfermato la nosografia (cioè la classificazione delle malattie mentali) dell'800, aggiornandola nella forma esteriore. Il paziente, reificato nella clausura e oggetto nudo dell'osservazione, è stato avviato ad un «decorso» pre-scritto nei libri e nella mente dei medici1.
Non si poteva sfuggire a questa logica se non abbattendo i manicomi, sacche di deposito per «abnormi» indesiderabili e calamite per processi di biologizzazione del sociale. L'eliminazione degli ospedali psichiatrici si è avviata nel nostro paese con la legge 180 che impedisce il ricovero asilare, proibisce la costruzione di nuovi manicomi e indica provvedimenti territoriali di cura e prevenzione. La legge 180 notoriamente è stata la conquista di un movimento di avanguardia2 che, scontrandosi talvolta con il potere tradizionale in una serie di situazioni locali (Gorizia, dapprima, in seguito Perugia, Arezzo, Trieste, Reggio Emilia, Ferrara) ha dimostrato nella pratica la possibilità dell'eliminazione dei grandi complessi ospedalieri e dell'organizzazione di adatte strutture nel territorio (reinserimento sociale dei lungodegenti, piccole comunità terapeutiche, centri di salute mentale, ricoveri di breve durata dei casi di urgenza negli ospedali generali, terapie domiciliari).
Le lotte contro i manicomi, insieme ai risultati di portata medico-sociale non calcolabili, hanno anche confermato che la nosografia psichiatrica è tutta da rivedere perché fondata in parte cospicua sugli artifici derivanti dall'isolamento e dalle vessazioni asilari; esse hanno denunciato quanto abbia influito la cappa manicomiale sul decorso di ciò che si annuncia come sofferenza psichica e viene via via interpretato, considerato e «trattato» come malattia. Non poche certezze clinico-medico-psichiatriche sono state demolite: sappiamo sempre meno che cosa è la malattia mentale; e sappiamo certamente di più su che cosa un essere umano possa fare di un altro essere umano.
Ma i risultati della lotta contro i manicomi non consentono di concludere che le malattie mentali non esistono, né che esse siano esclusivamente o prevalentemente il frutto delle contraddizioni sociali. Allo stato attuale delle conoscenze sarebbe rischioso, a questo proposito, confondere una pesante concausa addizionale - il manicomio, spia dei fenomeni di emarginazione sociale e massiccio volano patogenetico - con una causa primaria; e dire - o comportarsi come se si dicesse - che i processi di eliminazione sociale del diverso, debole e improduttivo, siano radice etiologica delle malattie mentali. Denunciare la violenza e l'esclusione nei rapporti interpersonali e sociali che precedono e favoriscono la comparsa conclamata del disagio psichico, il suo aggravamento, la sua cronicizzazione, non significa avere individuato l'essenza di questo.
Al rischio cui si è fatto cenno se ne aggiunge un altro: di comportarci come se la messa in discussione di una nosografia psichiatrica centenaria non fosse che un trascurabile epifenomeno tra i risultati delle lotte contro i processi di emarginazione sociale; come se l'unico aspetto importante ed evidente di quanto è stato realizzato contro i manicomi fosse quello politico e non anche quello specifico. Tali rischi appaiono tanto più grandi se si tiene conto che la psichiatria - non solo quella tradizionale, ma anche quella avanzata - si comporta molto spesso a livello «terapeutico» come se negasse quanto è avvenuto; come se la malattia fosse uno stato e non una condizione. Sappiamo che, oggi come ieri, il sintomo viene ridotto pesantemente al silenzio, anche se gli strumenti usati non hanno più la palese violenza dei tempi passati.
Ciò avviene in misura tanto più grande, quanto più è radicato e inestricabile il rapporto di interazione tra risposta «terapeutica» e domanda di assistenza. Ciò che continua ad essere richiesto è un intervento medico che obliteri l'ansia per il singolo e il disagio per il gruppo di appartenenza (famiglia, lavoro) e che riporti il comportamento alle apparenze della norma o almeno a un livello sopportabile di disturbo: tanto più che in molte situazioni un tale tipo di intervento trova giustificazione anche sul piano politico, non potendosi rischiare il clamore della protesta in contesti ancora divisi nella valutazione delle nuove esperienze
Dal manicomio al territorio
La legge 180 ha - giustamente e tempestivamente - eliminato i manicomi. Ma in questi non ci sono soltanto i malati. Alcune decine di migliaia di operatori psichiatrici si apprestano ad operare nel territorio a mano a mano che l'ospedale psichiatrico non ha più ragione di esistere; avendo incorporato tuttavia attraverso anni di vita istituzionalizzata una logica che nota il sintomo per ridurlo al silenzio ed il comportamento giudicato abnorme per opprimerlo.
Due, quindi, i fatti. Da un lato, gli psichiatri progressisti che sembrano badare di più ai risultati politici - di grande portata - conseguiti che non ai nuovi aspetti specifici dopo l'eliminazione dei manicomi; e che continuano a «mettere la malattia mentale fra parentesi» nella prospettiva di battaglie politiche a venire; dall'altro uno stragrande numero di operatori psichiatrici che si appresta ad un lavoro del tutto nuovo con strumenti non solo obsoleti, ma per lo più anche dannosi e che si oppongono all'originalità ed alla novità del lavoro stesso.
La scarsa attenzione nei confronti di questi fatti, unita alla realtà della introiezione da parte degli operatori di un modello medico tramandato dalla psichiatria tradizionale, potranno avere un'influenza determinante sui meccanismi di trapianto dell'ideologia manicomiale nel territorio dove sono sorti o sorgeranno nuovi servizi.
Vediamo in che cosa questi consistono. Come alternativa al manicomio, la legge prevede:
l) Unità per i casi di urgenza psichiatrica - i Servizi di diagnosi e cura - accorpate agli ospedali generali: 15 posti letto per ogni grande ospedale di zona. Il trattamento che ricevono i pazienti in questi servizi - fatte le note e citate eccezioni - è stato sinora non buono, sino a diventare pessimo in alcune città, soprattutto le grandi del Centro-Sud, dove le richieste di interventi di urgenza superano di gran lunga le possibilità materiali della risposta specifica. In questi servizi il silenziamento sintomatico è spesso violento (elettroshock, psicofarmaci ad alte dosi).
2) Centri di igiene mentale (CIM), piccole comunità terapeutiche, servizi di emergenza psichiatrica, equipes per cure domiciliari, ecc… In molte regioni questi servizi - tolti i CIM - sono allo stato di progetto. Anche quando la richiesta di intervento è contenibile al di fuori delle strutture ospedaliere, la risposta è prevalentemente di tipo farmacologico, con l'ausilio eventuale di interventi «psicologici», per lo più non bene definiti.
Eliminato l'ospedale psichiatrico, si presentano quindi, da un lato, i pericoli dell'esportazione, consapevole o no, volontaria o coatta, della logica manicomiale nel territorio; dall'altro, le strutture inefficienti e la carente preparazione degli operatori convogliano la domanda di assistenza verso le cliniche e le pratiche private, attente al riciclaggio delle vecchie ideologie ed all'apprendimento delle forme tecnologicamente nuove del controllo travestito da cura3. Tutto ciò mentre le strutture nate dalla lotta anti-istituzionale rischiano l'impasse di uno spontaneismo che era a suo tempo significante spontaneità operativa ed oggi, eliminato il manicomio, si muove in assenza - dati i tempi - di possibili obiettivi politici; e in assenza di obiettivi specifici, per timore di cadere in una «vocazione terapeutica» permeata di controllo.
Sottosviluppo e mancata «razionalizzazione»
Il lettore potrebbe esser portato a questo punto a dar ragione a chi afferma che la legge 180 è stata prematura: cioè che sarebbe stato meglio modificare progressivamente l'ospedale psichiatrico, dotare il territorio di strutture dapprima intermedie e poi concretamente funzionanti, procedere quindi al ridimensionamento sino all'eventuale eliminazione delle strutture di ricovero, in concomitanza con il completamento di quelle extramurali.
Dato che siamo contrari a questa tesi, la quale ha notoriamente trovato sostenitori a tutti i livelli politici, burocratici, tecnici, accademici e persino della magistratura4, dobbiamo qui chiarire il perché. A questo scopo partiremo dall'analisi di alcuni aspetti specifici della situazione psichiatrica italiana dal dopoguerra in poi, a confronto con le situazioni in altri paesi, per poi spiegare come gli interventi di razionalizzazione abbiano sempre e soltanto significato, in ambito psichiatrico, riproduzione e perpetuazione della logica istituzionale5.
Tutta una serie di schemi scientifici e culturali, che sono diventati parte integrante del bagaglio intellettuale di molti operatori psichiatrici dell'area occidentale nel periodo che va dalla metà degli anni '40 sino alla metà degli anni '60, hanno appena sfiorato o non hanno toccato per niente la realtà psichiatrica italiana. Questi schemi, tipico prodotto di una scienza e di una medicina del capitale sempre più diversificate nelle apparenze e sempre più totalizzanti nella sostanza, erano frutto dell'accostamento o della miscela di diversi ingredienti tratti dai vari settori delle discipline del comportamento e dai vari approcci in psichiatria. In parte essi contenevano - e contengono - spiegazioni in chiave eminentemente biologica della regolazione comportamentale umana, relative interpretazioni in chiave medica della malattia mentale, e proposte «terapeutiche» di tipo organico o somatico; in parte modelli e prassi ricollegabili ai molti filoni della psicologia e della psichiatria dinamica, soprattutto di impronta psicanalitica. Su queste componenti fondamentali si innestava l'indirizzo sociologizzante di derivazione soprattutto americana, volto a misurare i fenomeni psicosociali legati alla struttura produttiva e socioeconomica per fame oggetto di cauta critica, di limitate proposte di modifica, in ultima analisi, di razionalizzazione. Infine a questi filoni si andava affiancando tutta una vasta gamma di tecnologie di controllo comportamentale di stampo «ingegneristico» (il behavioral engineering di derivazione skinneriana) o addirittura poggianti su schemi punitivi di condizionamento pavloviano, come quelli illustrati sia pure in versione estrema nell'Arancia meccanica (le cosiddette terapie del comportamento, behavìor therapies)6.
Questa avanzata scientifico-culturale ed operativa dei modelli e delle pratiche di volta in volta psicobiologici, psicodinamici, sociologici e tecno-comportamentali non induceva il minimo fenomeno di razionalizzazione nella cruda realtà italiana. (Inutile discutere in questa sede quanto per pura arretratezza, e quanto invece perché di tale razionalizzazione non si sentiva la necessità, fidando nell'efficacia dei sistemi tradizionali di controllo e di esclusione). L'istituzione psichiatrica e tante altre con analoghe funzioni e significati restavano sostanzialmente dei luoghi di segregazione e di deposito dei «meno idonei» e degli «oramai inutili», teatri di innumerevoli sopraffazioni e violenze, territori franchi per l'esercizio selvaggio di «terapie» - nel caso dei manicomi la contenzione e l'isolamento, le varie forme di interventi punitivi fisici, l’impregnazione massiccia e prolungata con neurolettici. In altre parole, da noi non si andava minimamente affermando né la «nuova razionalità» biopsicologica e biopsichiatrica (quella che si propone di adoperare con rigore scientifico, con oculatezza e con raffinata diversificazione, tutta la vasta gamma degli strumenti organici, soprattutto psicofarmaci) né la «nuova coscienza» psicodinamica, cioè quella che vuole ospedali psichiatrici e centri di assistenza sul territorio trasformati in articolati laboratori psico ed ergoterapici, né infine il «nuovo tecnologismo» apparentemente asettico, dedito all'ingegneria comportamentale sugli anormali e sui disfunzionanti come necessario quanto logico complemento al controllo ergonomico sui lavoratori.
Malgrado «svolte storiche» come quella del centro sinistra, ancora meno andava passando l'utopia sociologizzante socialdemocratico scandinava o britannica, quella che popola il territorio di istituzioni razionali ed asettiche - gli ospedali psichiatrici moderni, i luoghi di lavoro protetto, le case per gli anziani - e anima tutto il fitto viavai di operatori sociosanitari che assistono e controllano l'ex ricoverato psichiatrico, il tossicomane, l'handicappato, l'anziano rimasto solo, per rendere meno visibile, attraverso la «repressione democratica»7, la contraddizione di un'emarginazione e di un disagio di massa. Nulla di tutto questo nel settore pubblico in Italia e, significativamente, pochissimo anche nel settore privato: lo prova la continua esportazione di pazienti da tutti i punti della penisola verso le istituzioni private e pubbliche all'estero, non giustificata, nel settore psichiatrico, da quelle esigenze di «tecnologia spinta» e di sofisticazione organizzativa che caratterizzano altre aree dell'intervento medico.
Tempestività di una legge
Non siamo qui per discutere quanto l'impossibilità di realizzare sia pure in minima parte trasformazioni avviate altrove, in un paese per molti versi semi-coloniale - incastrato negli schemi ferrei della divisione internazionale del lavoro, quindi subordinato, privo di solide tradizioni culturali-scientifiche di matrice borghese - abbia aperto lo spazio per la mobilitazione di un numero sempre maggiore di operatori attorno a ben altri obiettivi in tema di nuova psichiatria, e quindi consentito una serie di risposte positive, sul piano dell'evoluzione della domanda, da parte delle comunità in cui nascevano le sperimentazioni più avanzate. Di fatto le avanguardie psichiatriche di Gorizia, all'inizio degli anni '60, si sono trovate di fronte una situazione di miserabile degradazione istituzionale. Il progetto dell'eliminazione - non della riforma - del manicomio nasce di lì. La presa di coscienza della realtà primaria dei processi di emarginazione è tale da imporre una battaglia politica, a lato di un lungo lavoro di miglioramento dell'ambiente istituzionale. Ma questo lungo lavoro dimostra che, al di là delle intenzioni degli operatori, comunque si tenti di migliorare il manicomio, questo ripropone sempre le leggi dell’annichilimento e dell'esclusione sociale. Inoltre la pratica indicherà che la presenza di strutture intermedie territoriali non intacca in alcun modo la sopravvivenza dell'asilo psichiatrico.
Esperienza esemplare, sotto questo aspetto, quella di Reggio Emilia, dove, fra la fine degli anni '60 e la seconda metà degli anni '70, si tenta di aggirare il grande ospedale con servizi sul territorio che svuotino l'istituzione della sua funzione segregante. L'esperimento - forse, non ultimo, per una incerta volontà politica dell'Ente locale - si scontra con il manicomio, paradigma e calamita dei processi di emarginazione: i servizi sul territorio funzionano bene - e parallelamente l'ospedale continua a prosperare.
A controprova di questi fatti si pongono esperienze come ad esempio quella che è stata realizzata a Pordenone. Questa provincia non ha mai avuto un ospedale psichiatrico: l'assistenza per 270.000 abitanti è assicurata in modo soddisfacente da un servizio di diagnosi e cura e dal lavoro di un centinaio di operatori nei servizi dislocati sul territorio. Lo stesso a Città Di Castello in provincia di Perugia, dove i servizi territoriali (trenta operatori per 100.000 abitanti) forniscono un'assistenza di ottimo livello e dove la prevenzione dei ricoveri è fatto compiuto da anni.
La pratica ha dimostrato quindi che il manicomio è - sempre, comunque, degradato o modernissimo - trasformazione del disagio in malattia, codificazione clinico-nosografica di comportamenti devianti letti attraverso le griglie ermeneutiche delle ideologie che via via si alternano e si aggiornano. Ha indicato inoltre che i servizi territoriali possono funzionare bene e a costi contenuti; mentre i costi per il mantenimento del danno attraverso i grandi ospedali sono altissimi. Il manicomio, quindi, doveva essere eliminato: urgentemente, tempestivamente, prima che «riforme» di copertura ne riproponessero immutata la funzione, come altrove.
La cura e la prevenzione
Questo non vuol dire, ovviamente, svuotare di colpo l'asilo, mandare da un giorno all'altro i degenti all'esterno senza assistenza, come non poche persone hanno pensato (o fatto finta, strumentalmente, di pensare). Vuol piuttosto dire rendere impossibile l'accesso al grande ospedale psichiatrico a nuovi pazienti; e tentare di reinserire quelli che abitano in manicomio da anni e decenni in nuove piccole strutture dislocate nel territorio. Non si tratta di un lavoro che possa essere fatto in pochi mesi. In altri termini: impedire del tutto le nuove ammissioni e svuotare cosi la grande istituzione segregante del suo significato primario. Per i pazienti che erano in precedenza ospiti coatti e volontari dell'istituzione, resta la possibilità di una decisione caso per caso, sulla base dello stato di necessità, riguardo all'eventuale prolungamento del ricovero.
Il prezzo di questa operazione non può che essere pesante, e così il disagio per molti pazienti e per molte famiglie. Le porte dell'ospedale psichiatrico sono questa volta chiuse per chi vuole entrare (la logica si è capovolta); e le strutture intermedie spesso funzionano parzialmente o male. Le indicazioni della legge sono state a livello di Enti locali non di rado rispettate soltanto in parte, o grossolanamente disattese. Il disagio che ne deriva, come si è detto, è pesante, ma gli esempi citati dimostrano che esso è riparabile col tempo. Sappiamo d'altra parte con chiarezza che in alternativa resta la perpetuazione - sia pure in forme apparentemente mutate, sia pure con una politica di dentro-e-fuori (revolving door, porta girevole come negli alberghi) che tende ad abbreviare i ricoveri palleggiando i pazienti fra un asilo «razionalizzato» (o un moderno carcere) e le strutture territoriali8 - della logica del manicomio: cioè del luogo dove si segregano il disagio e la contraddizione, dove essi si trasformano in danno grave, irreparabile, sino ad una condanna a vita alla sofferenza ed alla disfunzione. Insomma, una volta fatta la scelta, si tratta di mettersi al lavoro in un'altra direzione, di convogliare le nuove energie - per alcuni, quelle residue - in una impresa difficile ed appassionante, in cui la negazione di ciò che fa male diventa cura, ricerca, prevenzione, oltre che crescita culturale, sociale e politica di chi è risparmiato dalla sofferenza.
L'eliminazione del manicomio riporta il conflitto, il disagio, la sofferenza nello spazio che divide e unisce gli esseri umani, spazio simbolico e reale, territorio dove la gente vive. Il territorio non è soltanto entità geografica, topografica, limitata o estesa, confinata o confinante; è prima di tutto luogo della relazione fra gli esseri umani nella loro contraddizione, nel loro limite, luogo dove il desiderio di libertà incontra la vita dell'altro come possibilità di comunicazione e come impedimento.
E’ scontato dire che le istituzioni sono necessarie e indispensabili per la vita della gente. E’ altrettanto scontato che la loro presenza può diventare copertura ideologica delle contraddizioni e dei conflitti che vengono esportati. Non possiamo fare a meno di istituzioni psichiatriche nel territorio. Sappiamo al tempo stesso per esperienza oramai accumulata che la cura delle malattie mentali si fa attraverso il lavoro attivo e disponibile degli uomini e non attraverso la costruzione di muri e la limitazione di spazi. In questo senso si presenta come punto nodale l'intervento nelle situazioni di emergenza psichiatrica, con l'intento, al tempo stesso, di cura e di prevenzione nei luoghi dove il malessere si presenta; poiché sul non-ricovero e sul non-uso di metodi di silenziamento brutale in corso di crisi si giocano sia il destino dei singoli pazienti, sia il successo del nuovo indirizzo che non deve portare ai reparti minimanicomiali.
In che modo, dunque, deve proporsi l'intervento nelle situazioni di emergenza? I provvedimenti di urgenza, si è detto, debbono prevenire l'invio in reparto psichiatrico di una persona gravemente sofferente e che presenta disturbi del comportamento tali da impedire o vanificare i tentativi di assistenza da parte del gruppo di appartenenza. Tale intervento deve pertanto rispondere ad una serie di requisiti essenziali: mantenere la persona malata nell'ambito in cui vive, conservando la continuità dei reciproci vissuti del gruppo familiare nel corso della crisi; rispondere ad una intollerabile solitudine; trascendere la situazione acuta cogliendone i significati per il gruppo e per il singolo; evitare la medicalizzazione della crisi, evento comunque minaccioso e destorifìcante.
Le chiavi di lettura del disagio psichico
Questo discorso ci conduce ancora una volta al significato dei sintomi soggettivi e oggettivi nel corso di una crisi acuta. La loro lettura da parte dell'operatore psichiatrico può esser fatta volta per volta nei modi più diversi. Chi esprime un delirio o soffre di allucinazioni o si comporta in un modo folle può avere nella sua storia una pesante, specifica eredità patologica; oppure può presentare all’esame clinico una costituzione che fa sospettare tendenze a disturbi mentali; inoltre certamente la persona in questione ha un temporaneo, alterato biochimismo cerebrale; può essere vittima designata di una dinamica che regola le leggi della comunicazione all'interno di un gruppo; o un emarginato da sempre espulso come diverso, senza casa, senza lavoro; o può aver avuto conflitti con genitori violenti, freddi o iperprotettivi; e cosi via.
Qui si schierano le varie scuole, vecchie e nuove, tradizionali e alternative: e si divaricano i vari modi di intervento. Nei confronti dei sintomi intervengono i biologi della ereditarietà, della costituzione del comportamento, vedendoli come spia di un alterato funzionamento organico che richiede dì essere riportato alla norma, cioè all'assenza di segnali di questo genere. I fautori delle terapie re1azionali esamineranno - e tenteranno di modificare opportunamente - la circolazione di messaggi, e tra questi i sintomi, all'interno di un piccolo gruppo (la famiglia).
Non pochi dei nuovi psichiatri sosterranno che i sintomi sono spia di processi di emarginazione della persona in questione vittima di una spietata logica sociale. Gli psicanalisti, a loro volta, proporranno un'interpretazione che vuole riportare un vissuto e un comportamento anomalo alla loro matrice conflittuale.
In altre parole la lettura dei sintomi, se può essere di aiuto all'operatore per comprendere meglio la condizione del paziente, può permettere, e abbastanza di frequente, di inquadrare il malato in uno schema volta per volta biologistico, genetistico, costituzionalistico, relazionalistico. politico-socio-logistico, psicanalistico. Tutti questi termini suonano male e non senza ragione, dato che indicano procedimenti ideologicamente riduttivi (e perciò totalizzanti) tra loro intercambiabili. Quindi l'apparente diversificazione dei tipi di intervento riconferma il potere delle scuole, delle tendenze, delle competenze, della settorialità del sapere. In altri termini, riconferma la tendenza a dividere i campi dì intervento e le specialità secondo l'ideologia dominante.
Quest’ultima non chiede che i segnali di sofferenza vengano compresi nel loro significato, ma che vengano imbavagliati e riportati all’ordine che non è soltanto rivolto al recupero della produttività, o viceversa all'esclusione di chi è irreparabilmente improduttivo, ma che vuole rassicurazione, appianamento delle contraddizioni, complicità dei tecnici i quali si dividono la torta del potere specifico.
Il risultato di questo, al di là e nonostante ogni rivoluzione psichiatrica, potrebbe essere che domani avremo una psichiatria dei lumpenproletari assistiti da operatori neo-psichiatrici i quali troveranno nei loro pazienti riconferma di quanto è stato a suo tempo giustamente sostenuto (e non tenendo conto del fatto che molti altri pazienti si rivolgono alle cliniche e pratiche private); una psichiatria degli psicanalisti che selezioneranno fra la popolazione psichiatrica i pazienti adatti alla riconferma delle loro ipotesi; una psichiatria dei biologi che troveranno certamente chi è disposto a seguirli sulla strada maestra delle loro tautologie unidirezionali; ed una psichiatria della famiglia e del piccolo gruppo che troverà i suoi seguaci offrendo una risposta «moderna» che alimenterà a sua volta la domanda. E così via.
Ma questa non sarà la nuova psichiatria, ma semplicemente quella di un tempo opportunamente imbiancata e con l'aggiunta di nuovi settori di influenza e di nuove aree di potere. In tal modo, i segnali della sofferenza provocano interventi che sono espressione delle varie «scuole» e riflettono l'immagine che l'operatore si è fatta del paziente; ma sono per lo più provvedimenti ideologici e non risposte ai bisogni del malato in quel momento, in quella situazione.
I sintomi della crisi continuano ad essere visti come spia di un'altra cosa, e come tali devono essere riportati alla loro matrice. Ma la loro matrice appare come un fantasma dai reiterati travestimenti. Nel frattempo succede sempre, dappertutto, la stessa cosa: viene ridotto al silenzio un tentativo disperato, talvolta indecifrabile, di continuare a comunicare in una situazione di emergenza, di mantenere vivo un rapporto anche quando gli strumenti della comunicazione sono divelti e confusi. In altre parole, i sintomi non chiedono di essere acriticamente riportati alla norma, dato che l'anormalità che essi rappresentano non vuol dire necessariamente difetto di salute: essi chiedono prima di tutto disponibilità, presenza, tempo, da parte di chi assiste; e possono spontaneamente regredire del tutto, tanto più quanto più l'assistenza nella condizione di crisi è stata caratterizzata da interventi tempestivi e non violenti, da cautela, da attesa9.
L'esigenza di leggere al di là dei sintomi la realtà dei bisogni del paziente inserito nella sua storia e nella storia è certamente legittima; lo diventa meno quando appare come operazione riduttiva compiuta via via dai biologi, dagli psicanalisti, dai sociologi; e quando dà giustificazione ad un comportamento di attivismo politico che tanto più rischia, oggi, di degradare a rassegnato fatalismo.
PSICANALISI E CONSUMO:
METAPSICOLOGIA E METASTORIA
(Giornale Italiano di Psicologia, Volume VIII, n. l, aprile 1981)
Michele Risso e Paolo Repetti
Nell'ambito dell'ormai assestato consumo della psicanalisi, tenteremo di esaminare un aspetto di quel fenomeno, espresso da una parola pesante, rassegnata e ormai ampiamente consumata. La parola è: riflusso. La nostra indagine sarà parziale e rischierà di essere semplicistica e riduttiva. Ma il terreno sul quale ci muoviamo non è facile.
La cultura che ha animato la giovane generazione del '68 non è certo quella della contraddizione e del dubbio, ma quella della estrema opposizione, della aspettativa escatologica, della negazione totalizzante dell'ordine e dello spazio storico presenti. D'altra parte questi ultimi sono, in misure diverse, connotati strutturali di ogni movimento politico nel suo sorgere, soprattutto quando lo scopo non vuole essere la semplice modificazione di elementi interni al sistema, ma la messa in discussione globale dei codici attraverso cui una società modella il rapporto di ogni individuo col mondo. Il rischio è che questa forte tensione emotiva che marca l'inizio di ogni movimento di opposizione, facendo della sua nascita una piccola palingenesi, diventi col tempo cintura protettiva, resistenza al reale e alla necessità che quest’ultimo venga attraversato e trasformato. La negazione del presente non si traduce in una serie di strategie e di prediche d'intervento e d'azione sul reale, ma diventa essa stessa «soluzione» immediata di una realtà e di un presente conflittuali. Diventa cioè la parola piena che vuol porre fine a qualche cosa e segnare l'inizio di un'altra cosa. Un'illusione, un sogno, un annuncio come se fosse nata la possibilità di vivere non più in uno spazio storico, ma in uno spazio finale1.
Il '68 è stato il grande periodo della corale «scarica motoria», del «deflusso libidinale» (per usare qui termini psicanalitici che indicano liberazione; ma il dito che indica la luna non è la luna). Un detto come immagination au pouvoir non vuol dire che il desiderio sia quello di gestire il potere con immaginazione, ma che l'immaginazione ha gambe che corrono alla conquista del potere. In realtà, si mettono in moto moltissime cose e vengono convogliate energie immani in una serie di grandi battaglie: ma l'immaginazione non conquista il potere: immagina di conquistarlo. Il grande fervore dell’immaginazione («tutto e subito», «siate realisti: chiedete l'impossibile») alimenta ed esaspera aspettative fantasmatiche che si scontrano con la durezza dei fatti: il desiderio si arrampica sullo specchio di una realtà che si mantiene repressiva, che ha saputo organizzarsi senza immaginazione o senza progetti che non siano quelli dello sviluppo2 ma con efficaci sistemi di controllo; e lo scontro con questa realtà si ripete per anni. Infine il desiderio «prende corpo» nei sintomi sociali: l'eroismo delle tossicomanie pesanti; la realizzazione della componente distruttiva attraverso la violenza armata; lo spostamento dell'orizzonte geografico di attesa verso l'oriente dei guru (l'India sostituisce il Vietnam).
Oppure: diventa desiderio di essere liberati, qui e ora. Attraverso la psicanalisi. Così si parla di bisogno di psicanalisi. Detta la parola «bisogno» scatta il corto-circuito bisogno-consumo. Quando aumenta la richiesta, tende, ove possibile, ad aumentare l'offerta; purtroppo è vero anche il contrario: l'aumento dell'offerta fa lievitare la richiesta. Ma dietro la scorza delle richieste ci sono in realtà domande che vorrebbero un si o un no. Queste domande rimangono spesso senza risposta, ché l'interlocutore fa il sordomuto; talvolta non c'è risposta possibile, fatto, quest’ultimo, male sopportato. Lungo il cammino della frustrazione, le domande diventano richieste, le risposte diventano proposte che indicano prodotti (questo, quello), luoghi (qui, là), tempi (prima, dopo).
Il numero dei consumatori della psicanalisi sta aumentando in modo vistoso. Non parliamo soltanto dei consumatori di terapia psicanalitica, ma di coloro che leggono di psicanalisi, che parlano di psicanalisi, che sognano di psicanalisi (o sognano di fare un'analisi, nella quale raccontano i loro sogni). Le librerie sono stracolme di opere di psicanalisi, di riviste.
È difficile capire, in un contesto che dà risposte apparenti e distorte a domande fatalmente male espresse, quale sia la realtà e quale l'induzione del bisogno. Certo è che ciò che viene consumato è un prodotto, effetto di una manipolazione, come effetto di manipolazione è la veste formale del bisogno espresso. Forse chi esprime la richiesta - parliamo ormai di esprimere una richiesta, non di porre una domanda - ha addirittura dimenticato ciò che in principio voleva (o voleva sapere). Ora, purtroppo, tutti quelli che suonano per la prima volta alla porta di uno psicanalista hanno - letteralmente - dimenticato ciò che volevano: il che li mette in una condizione di rischio non lieve.
L'aumento del consumo di psicanalisi provoca un aumento incontrollato del numero degli psicanalisti. Questo è un problema tutt’altro che trascurabile3. Ma al di là di questi fatti ci si rende conto che qualcosa sta cambiando con l'aumentare spropositato delle richieste di terapia e cultura psicanalitica. Infatti, l'aumento di consumo della psicanalisi provoca la necessità di un ripensamento teorico e, forse, la modificazione di una prassi che, sino a pochi anni fa, era rigida nel suo setting e nel suo codice. Che cosa diventa ora questa disciplina? Si chiude ancora una volta nella sua torre d'avorio, oppure può mettersi in discussione e vedere cosa succede quando un sapere elitario diventa istanza, alla quale si richiede il risana mento di un disagio di natura sociale?
La richiesta di questo risanamento può essere rifiutata e discussa quanto si vuole: ma c'è. Ed essa porta nello studio dello psicanalista una serie di linguaggi ben lontani dalla voce della borghesia viennese dei primi del secolo e della borghesia anglosassone dagli anni '40 in poi; e porta realtà diverse di nuovi gruppi emergenti. E’ chiaro che la contraddizione si pone prima di tutto all'interno di questa richiesta di risanamento. Su questo aspetto uno di noi ha scritto recentemente un breve articolo di cui citiamo alcuni brani:
In ogni caso la richiesta di psicoterapia è vastissima soprattutto da parte di chi, avendo investito la propria «irrequietezza» sul terreno della lotta politica, ora si sente letteralmente mancare la terra sotto i piedi ... Purtroppo la dimensione collettiva della POLITICA, cui si affidava in maniera spesso acritica e troppo immediata il compito di dare alla propria storia individuale un senso più ampio sembra essersi frantumata; e non è facile sostituirla. Basti pensare all'enorme richiesta ed esigenza di «comunicazione» cui essa veniva incontro fornendo dei codici comuni alle parole e ai gesti delle persone, alla possibilità che essa dava di tradurre in azioni finite malesseri, stati d'animo e inquietudini d'altra natura. «Siate realisti: chiedete l'impossibile» ... E’ forse sul filo di questo «impossibile» che il desiderio fa sentire la sua voce: prima quella corale, perentoria e intransigente della lotta politica, ora quella frantumata, dubbiosa, a volte intima del dialogo terapeutico (Repetti, 1980).
La richiesta di risanamento è dunque contraddittoria. Ma pone un problema alla psicanalisi. O si chiede a questa disciplina ciò che essa non può dare; oppure la psicanalisi è qualcos'altro che la cura pluriennale di singoli pazienti nevrotici. Se è vera la prima ipotesi, sarà necessario chiarire un malinteso. Ma se è vera la seconda ipotesi, si impone tutta una ridefinizione della psicanalisi.
Nel frattempo si eviti un inganno. Non si comporti lo psicanalista come se fosse in grado di soddisfare il bisogno di psicanalisi (si pensi ai tempi in cui si parlava di bisogno di comunismo e si faceva grande consumo di comunismo), ma come la controparte di un dialogo durante il quale si sperimenta che il desiderio non trova - spesso - risposta.
Vediamo di articolare meglio questo punto. Il paziente si pone, rispetto all'analista, come «oggetto in balìa» (Montefoschi, 1977) di una sofferenza che non controlla e che è costretto a subire; egli chiede all'analista di «intervenire» su questo disagio che egli chiama di volta in volta «sintomo», «malattia», «conflitto». L'analista, agli occhi della maggior parte dei pazienti, è dunque colui che, dicendo che una cosa vuol dire un'altra cosa, ha il potere di smascherare il male che si traveste in sintomo, di individuarlo collocandolo in un'accertabile cronologia, di eliminarlo. La condizione è che il male sia presentato come un nome, una cosa, un evento; Pierre Legendre direbbe: come una formazione dogmatica (Legendre, 1976).
Consideriamo ora la relazione magica che si instaura tra lo stregone e il malato; in essa si parla di qualcuno che è posseduto dal male, che ha assunto il male dentro di sé, che è stato colpito dal male; e di qua1cun altro depositario del potere di liberare la vittima mediante un rituale. Nell'ambito del magico, la reificazione del disagio è quindi condizione della possibilità di esserne liberati. Il cerchio che lo stregone traccia intorno ai piedi del suo paziente delimita lo spazio malato e la terra cui il malato ha trasmesso per contiguità il suo male. Questo cerchio serve dunque a marcare simbolicamente, temporalmente e spazialmente, il limite fra il male e ciò che è fuori di esso, cioè quell'esterno purificato dalle contraddizioni che inevitabilmente segnano il qui e ora della malattia. «L'esterno» si pone quindi come luogo metaforico e reale «evocato»per distruggere il disagio e consentire il «ritorno» ad uno stato di sanità. La divisione tra «dentro» e «fuori», limitando simbolicamente lo spazio, «elimina» il tempo storico e permette quel processo di destorificazione del negativo che argina la crisi della presenza (De Martino, 1958, 1959). L'evocazione della descritta esteriorità, di questo al-di-fuori da cui il male è assente, è affidata nel mondo magico al rituale mediato dal potere dello stregone: egli è garante del trascendimento metastorico della sofferenza. Con un'operazione che potremmo dire di chirurgia magico-rituale è stata escissa la sezione malata dal corpo presupposto sano.
Ora, ogni volta che all'interno di un rapporto terapeutico l'analista si pone nei confronti del paziente come colui che è depositario di un sapere e quindi di un potere in grado di guarirlo (nel senso di farlo «saltare fuori dal cerchio», di porre fine al suo male), il rischio che si corre è quello di riprodurre un'esperienza simile a quella magica. Le parole dello psicanalista non farebbero altro, in questo caso, che ricostituire un «luogo» la cui caratteristica corrisponderebbe, appunto, a quella «esteriorità» riproposta al paziente come regime di verità con il quale questi possa difendersi dalla prova di realtà (Rella, 1979).
Quale è dunque la posizione dell'analisi di fronte all'aumentare della domanda? Occorre qui tentare di storicizzare il fenomeno, di tenere conto delle condizioni storiche nelle quali la domanda stessa è maturata, per poter impostare correttamente il problema. Si tratta di condizioni storiche segnate da qualcosa che non è avvenuto, da una mancata risposta alla aspettativa - anche se negata, anche se contraddittoria - di un ruolo nell'ambito di un progetto, di un ciclo produttivo. L'impazienza del desiderio che si traduce in rabbia, in ribellione, urgenza, non ha potuto tradursi in un progetto razionale di cambiamento, e per la sua natura e per lo scontro con meccanismi che l'hanno congelata nella sua originaria identità. Il sociale, per mantenere intatto il suo equilibrio, si arrocca su posizioni di intransigenza, sviluppa strategie di emarginazione che escludono, appunto, dal sociale, queste forze che lo minacciano. Si prolunga in questo modo «l'età del desiderio»: facendo intendere, al tempo stesso, che all'interno del desiderio non ci sono istanze positive, né nuclei di una possibile verità.
La psicanalisi entra in scena quando le richieste non sono più traducibili sul piano di una pur precaria organizzazione collettiva o politica; c'è una frantumazione, rimangono degli individui che spesso fanno riferimento alla loro precedente identità sociale e di classe. Di fronte a questo disagio la psicanalisi non può candidarsi come àncora di salvezza, come sostituzione di ciò che non è avvenuto nel sociale, né come pratica di reintegrazione degli individui all'interno di quella stessa logica che li ha tenuti lontani come persone prive di destino. L'analisi non è la salvezza perché, in tal caso si costituirebbe, come tutte le salvezze, come luogo catechistico di liberazione, come promessa la cui realizzazione è legata al perpetuarsi di una fede. Essa deve continuare a porsi come processo critico e contraddittorio vissuto nell'ambito di una relazione duale all'interno della quale è possibile la ricerca di un nuovo modo di relazionarsi agli altri e ai propri vissuti.
Ogni tentativo di eliminare l'irriducibile, contraddittorietà della relazione psicanalitica, ne induce una immagine di scienza capace di dare delle risposte codificate per tamponare, trascendere, «eliminare» quel particolare disagio cui si dà il nome di conflitto. Il rischio è, insomma, che il sapere analitico si cristallizzi e diventi esso stesso una delle resistenze più forti al processo analitico. Né l'analisi può, per fornire delle risposte, tradursi in una «nuova immagine del mondo», in una filosofia della vita, o in un rituale in cui l'analista chiede al paziente la conferma del suo potere, o, infine, in un'alleanza simbiotica che ha come fine la reciproca rassicurazione e l'ancoraggio ai moli che proteggono le identità. In altri termini: un’area metastorica topos della destorificazione del negativo (De. Martino 1958, 1959).
Ben altro è l'analisi per Freud. Essa è interminabile nel senso che il discorso dell'analista non può darsi come «parola piena» costruita fuori della relazione vissuta col paziente e, quindi, non può fungere da termine cui approdare alla fine del viaggio. Essa però termina di fatto (e cioè nella prassi) quando il paziente arriva alla coscienza che la possibilità di trasformazione esiste solo come «modo di esistenza che dura quanto dura la sua vita» (Montefoschi, 1977). L'analista non può liberare il paziente dalla inevitabilità dell'alienazione, non è questo il suo ruolo; scopo dell'analisi semmai è che il soggetto che vive «nella alienazione della sua verità», riesca a vivere nella «verità della sua alienazione». Questo significa che c'è una strada da percorrere, ma che il punto d'arrivo è assumere su di sé la precarietà del proprio destino. La risposta della analisi al disagio non viene dunque dall'esterno come parola oracolare o divina, come risposta del maestro al discepolo, di chi sa a chi manca di questo sapere (Blanchot, 1977). Il lavoro analitico tenta semmai la decostruzione di ogni parola piena, sia quella di un sapere, di un sintomo o di un ordine dogmatico.
Le utopie che hanno mosso la gente negli anni passati contenevano certo quello che Freud chiama un «frammento di verità storica»; ma il senso che esse fornivano alle azioni del presente era in parte attinto a quel luogo irraggiungibile e senza storia che - come indica Lacan - è perso dietro le nostre spalle. Se (ci si consenta la metafora) quello che abbiamo davanti è uno specchio che riflette un miraggio (o un'utopia) situata alle nostre spalle, allora è possibile che per dare attualità al miraggio senza infrangere lo specchio ci si blocchi in un movimento frenetico per restare fermi. Compito della psicanalisi non è quello di eliminare il miraggio, né quello di cancellare l'utopia. È lo specchio che deve essere «infranto», «attraversato»; questo per togliere al movimento l'illusione di una frenesia appagante, sostituendola con la necessità di un difficile percorso.
BIBLIOGRAFIA.
BLANCHOT M. (1977). L'infinito intrattenimento, Torino, Einaudi, p. 319.
DE MARTINO E. (1958). Il mondo magico, Torino, Einaudi.
DE MARTINO E. (1959). Sud e magia, Milano, Feltrinelli.
LEGENDRE P. (1976). Gli scomunicanti, Venezia, Marsilio.
MONTEFOSCHI S. (1977). L'uno e l'altro, Milano, Feltrinelli, pp. 27, 78-79-80.
RELLA F. (1979). Il discredito della ragione, In Crisi della ragione, AA.VV. (Torino, Einaudi) pp. 147-179.
REPETTI P. (1980). L'inconscio selvaggio, L'informatore librario.
CRONICITÀ E CRONIFICAZIONE
(SAPERE – Agosto-Settembre 1981 - pag. 53-56)
Michele Risso e Paolo Repetti
«Senza speranza non è realtà ma il sapere che - nel simbolo fantastico o matematico - si appropria realtà come schema e cosi la perpetua» (Horkheimer e Adorno 1947)1.
A partire da queste parole si sarebbe tentati di pensare che ancor prima che nella pratica medica, nella stessa «volontà di sapere» si annida il rischio di ogni cronificazione. Per «conoscere» la realtà occorre interrompere il viaggio, farla passare attraverso le maglie di un sapere che in qualche modo la «inchioda» per poterla assumere come oggetto di discorso. Il marxismo a suo tempo e la stessa scuola di Francoforte, hanno messo bene in mostra che la realtà che scorre nei binari ciechi di certe scienze non è altro che ideologia e cioè perpetuazione di una visione distorta del reale. D’altra parte, la critica dell' ideologia non di rado si è appoggiata, per smascherare la tendenza di ogni sapere a fondarsi dogmaticamente, su una logica unidirezionale che voleva demistificare gli inganni, scovare le interdizioni, denunciare le repressioni di certe pratiche discorsive: riuscendo tuttavia raramente a descrivere e spiegare i meccanismi tramite i quali queste pratiche si affermano, producono un sapere, degli effetti di verità, un sistema di enunciati con tutte le conseguenze pragmatiche e teoriche che questo comporta. Da questo punto di vista una ricerca sul concetto di cronicità nelle malattie mentali, non può risolversi, almeno da parte di chi ne mette in dubbio la validità, in una semplice accusa a quel potere che servendosi del discorso psichiatrico, controlla, isola, rinchiude follia nel tentativo di «guarirla». Essa deve essere in grado di ricostruire la rete dei presupposti culturali che la psichiatria assume come pertinenti nel momento in cui, costruendo il suo malato-modello e le tecniche per intervenire su di lui, rende possibile un sapere della cronicità. Interrogando la psichiatria lungo il versante della sua storia si può notare come di fronte a un comportamento deviante che non muta, che persiste e non si modifica essa non sceglie di analizzare il proprio «sguardo» e i criteri e i parametri che esso utilizza per poter dire che qualcosa non muta; essa sceglie la fissità di una definizione, di un nome: cronicità. Da allora quel comportamento non parlerà al suo orecchio (ma sarebbe più corretto dire al suo occhio) se non con la voce che essa le ha dato, voce che confermerà l'esattezza della diagnosi e il pessimismo della prognosi.
Il corpo del malato diviene dunque il teatro di una verità contenuta negli schemi di un sapere quantificatore che riduce un comportamento deviante nelle formule di un lessico biologico-evoluzionista che parla di fasi acute, transitorie, cicliche ecc ... Preso all'interno di questa morsa, il folle non ha che una alternativa: o «guarire» o diventare cronico sapendo che, inserita nello spazio linguistico della medicina, la guarigione non sarà altro che il corretto funzionamento di un organismo secondo il modello della macchina.
Non si può, infine, non sottolineare che in psichiatria la diagnosi di cronicità si caratterizza molto meno per ciò che consente di sapere che per ciò che permette di fare: l'aspetto cognitivo è schiacciato da quello pragmatico, il mandato della scienza da quello sociale2. L'ospedale psichiatrico è il luogo in cui tale concetto dimostra la sua forza operativa. Il manicomio, infatti, non «attende» (ad) altro che (a) dare uno statuto definitivo a quel brulicare informe che è la follia vista dalle sponde tranquille della normalità. L'Ospedale e il cronico si strutturano dunque a loro reciproca immagine e somiglianza: al loro interno non «succede niente» o meglio, ciò che succede è niente; il loro tempo non si definisce a partire da un' azione o da un processo, ma da una stasi e da una persistenza. Il concetto di «cronicità» è stato, fin dalle origini della psichiatria, l'elemento fondante per una definizione, la più oggettiva e ristretta possibile, della follia. Verso la fine del '700 Vincenzo Chiarugi inizia il suo trattato sulla pazzia scrivendo: «La voce toscana pazzia, che a quella di saviezza si contrappone nel suo più stretto e vero senso significa: un delirio cronico e permanente». La cronicità è dunque l'elemento pertinente per distinguere «le semplici leggerezze di spirito» dalla follia. Per spiegare compiutamente questa distinzione il Chiarugi fa sua la definizione di Girolamo Fracastoro, vissuto nel 1300. «Insanus is erit, qui aetate ac tempore debito, et per se, non momentaneam et fugacem, sed confinatam impotaentiam habeat operandi circa intellectum»3. «Per se», vuol dire, appunto, per cause legate esclusivamente al soggetto: il termine «confinatam» può essere tradotto con «che gli è propria», «connaturata». Seguiamo ancora il Chiarugi: «È solo la persistenza ad agire contro il costume e la ragione che ce li fa riconoscere come pazzi ... ». « ... Così debbono essere escluse dal rango di pazzia, in quanto al tempo, quelle forme di delirio degli ubriachi, dei sonnambuli e dei fissati che fuori di queste circostanze non penserebbero o agirebbero come si vedono in certi momenti pensare e agire ... ». Allo stesso modo: «Le febbri che danno delirio non nascono da un cronico attacco diretto al cervello, e si dileguano al cessare delle affezioni primarie». Inoltre: «Se si conoscono le cagioni di un comportamento, esso apparirà ragionevole anche se in superficie può sembrare pazzo». Quindi: « ... gli appassionati ... possono essere considerati pazzi solo nel caso che sia una passione senza intervalli continuata ... ». Non possiamo quindi parlare di follia « ... in tutti quei casi in cui manca quel carattere di cronicismo che alla pazzia è essenziale»4. Follia è dunque ciò che dura nel tempo indefinitamente. Quando la persistenza di un comportamento deviante è tale da far escludere che esso sia una reazione ad una causa esterna (sia essa una febbre o una costrizione esistenziale) allora la causa non può che essere ricercata in un'alterazione connaturata appunto al soggetto. Siamo alla fine del '700: l'estendersi dei grandi agglomerati urbani, l'afflusso dalle campagne, la nuova organizzazione del lavoro, i radicali mutamenti della vita sociale impongono la necessità di una gestione organizzata della follia. Prima confuso tra delinquenti, vagabondi e prostitute, ora degno di attenzione medica, il folle viene liberato dalle catene. Nel corpo di questo essere strano, la malattia circola alla ricerca di un «dove» organico, dato che sofferenza e alterato comportamento non possono continuare a proporsi indefinitamente come tali e devono essere compresi in un fenomeno «universalmente» oggettivabile. La psichiatria non si domanda molto sul perché e sul come della follia e si concentra per sapere cosa il folle ha. In attesa di un giudizio medico illuminante, agirà tuttavia un pregiudizio sociale, una discriminazione che si rivolgerà soprattutto al comportamento deviante. Il folle disturba, è imprevedibile, non lavora, ha bisogno di assistenza. I perché rimasti senza risposta confluiscono in un dove istituzionale, nell' ospedale psichiatrico. Ospedale che si organizza, e si struttura nel solco dell'ideologia medica. Citiamo Foucault: «Strumento di osservazione, l'ospedale - l'Autore si riferisce alla clinica medica - doveva essere il luogo in cui tutte le malattie potevano essere classificate le une rispetto le altre, confrontate, distinte, raggruppate in famiglie, ciascuna poteva essere osservata nei caratteri specifici, seguita nella sua evoluzione, individuata per ciò che poteva avere di essenziale o di accidentale. L'ospedale: orto botanico del Male, erbario vivente dei malati ... Ma per un altro verso si presumeva che l'ospedale esercitasse un' azione diretta sulla malattia: non solo permetteva di rivelare la propria verità agli occhi del medico, ma le permetteva anche di produrla (il corsivo è nostro) ... infine nella sua verità fino a quel momento impedita e ostacolata»5. Nel secolo XIX i manicomi contengono persone aventi in comune comportamenti affini nella devianza psicologica e sociale. Nel manicomio avviene la trasformazione del messaggio dell'alterato comportamento e della sofferenza nel sintomo della malattia che si ripeterà, con l'aiuto dell'artificio asilare, agli occhi del1o psichiatra. Ciò darà conforma della fondatezza di una ipotesi che diventa diagnosi, di un fatalismo naturalistico che diventa prognosi e della apparente spontaneità di un decorso in realtà fortemente condizionato dall'isolamento e dalla violenza. La psichiatria sembra chiusa nella contemplazione di una malattia la cui evidenza è alimentata dallo stesso sapere psichiatrico. Questo non può fare altro che osservare il paziente attraverso il filtro delle norme prescrittive (cioè sociali) le cui infrazioni verranno interpretare come trasgressione di norme costituite (cioè biologiche)6. Due i binomi in questione: normadevianza e salute-malattia.
L'osservazione psichiatrica convoglierà nel letto della clinica le alterazioni del comportamento tenendo un occhio chiuso sulle contraddizioni della realtà sociale, dato che l'altro deve rimanere ben aperto e vigile sul sintomo (e sul microscopio). Il sintomo - in realtà il comportamento deviante a livello sociale, interpersonale, intrapsichico - verrà considerato esclusivamente come la materializzazione di una mancanza rispetto ad un ideale: la salute. Così il binomio norma-devianza non compare sulla scena della grande rappresentazione clinica degli asili; e il muro dell' ospedale nasconde ciò che in realtà in esso avviene: il controllo e la custodia di elementi che disturbano il vivere sociale. L'osservazione clinica si concentra sul sintomo: su di esso si elabora un tipo di sapere (di natura classificatoria); ma non si concede al sintomo alcun tipo di sapere. Così il malato entra un mondo in cui il futuro esiste già e sta scritto sui libri di un altro che lo osserva.
Lo sguardo oggettivante della medicina priverà dunque il mondo del folle (il suo discorso) della possibilità di essere visto come creazione umana (come un qualcosa che contenesse una «verità» da ascoltare) e tenterà di assimilarlo al mondo della natura.
A questo punto cosa può voler dire cronificazione? Potremmo dire che si tratti della reificazione forzata e quantificante della qualità di un comportamento - la follia - che si ripropone nel tempo. Ma la reificazione può avvenire soltanto localizzando nello spazio e misurando nel tempo, appunto, questa qualità; lo spazio - chiuso - è l'ospedale; il tempo è scandito dalla osservazione medica. Ora, reificazione è traduzione di qualità in quantità e trasformazione di comportamento in sintomo; nel tentativo di riportare il sintomo all' organo malato. Cronificazione è osservazione distorta e accurata della «cronicità» di una particolare condizione umana - e sottolineiamo la contraddizione dei termini cronicità e condizione umana nel tentativo di vederla naturalisticamente come uno stato. In altre parole, la cronificazione è conseguenza di un atteggiamento di chi osserva nei confronti di chi è osservato. È chiaro che qualcosa non può diventare cronico per qualcun altro se non attraverso la mediazione di un codice; ed è superfluo aggiungere che le regole del sistema di significazione le stabilisce chi osserva. Ora l'ideologia della cronificazione consiste nel presentare come motivato il rapporto tra gli elementi associati dal codice quando invece esso è arbitrario. L'attestazione della cronicità è sottesa dunque all'elaborazione di una griglia ermeneutica tramite la quale si assumono come pertinenti del comportamento di una persona alcuni tratti (sintomi) ai quali si assegnano modalità di esistenza secondo una logica naturalistico-evoluzionistica: il tratto cresce, permane, si stabilizza, si modifica, sparisce, ricorre, ecc ... La diagnosi di cronicità sancisce la definitiva esclusione del malato di mente dal consorzio sociale, la sua pietrificazione in un mondo senza storia nel quale il cambiamento viene visto come un incidente in una struttura che non prevede modificazioni. Occorrerebbe interrogarsi, infine, sul motivo per cui la maggior parte dei pazienti che diventano cronici nell'ospedale psichiatrico provengono dalla grande area dell'emarginazione sociale7. Non si vogliono qui stabilire in modo meccanicistico nessi causali diretti fra emarginazione e malattia. Certo è che un percorso molto breve separa l'esclusione da un ciclo produttivo, dall'esclusione dalla vita sociale: gli inabili al lavoro diventano inabili alla vita e la diagnosi di cronicità consente di rimuovere una contraddizione propria del sistema sociale e di tradurla in un’ entità diagnostica, medica che dia uno statuto definitivo a quella improduttività che, alle soglie del sociale, rischia di rimanere incontrollata. Privati dunque della possibilità, di elaborare un qualsiasi progetto, abbandonati a se stessi, spesso soli e senza più legami famigliari, questi pazienti finiranno la loro vita nell’ospedale psichiatrico con la qualifica di malati mentali cronici: ci si chiede se la vera malattia cronica non si trovi, fuori dal loro corpo, nella loro condizione sociale, prima e nella struttura che li ospita, dopo. A un secolo di distanza da Chiarugi, Kraepelin dividerà le malattie mentali in «curabili» (quelle dipendenti da cause esterne) e «incurabili» quelle causate da fattori costituzionali innati, endogeni. Secondo Kraepelin alcuni pazienti guariscono naturalmente (i malati maniaco-depressivi), altri, altrettanto naturalmente, non guariscono o peggiorano. Non solo l'esito della malattia incurabile - dementia praecox - è precostituito, ma così pure il suo corso. Uno dei punti caratteristici del sistema kraepeliniano è l'atteggiamento prognostico, strettamente collegato alla diagnosi.
Si diagnostica la prognosi e, se la prognosi si dimostra da ultimo esatta, anche la diagnosi viene considerata esatta8.
Giusta quindi l'osservazione di Foucault: il medico è convinto che l'ospedale permetta alla malattia di rivelare la propria verità, di produrla addirittura. Lo psichiatra sembra non essere sfiorato dal dubbio di coltivare una serra dove le piante degenerano secondo un progetto che è, almeno in parte, nella mente dello psichiatra stesso.
Sono passati cento anni dall'epoca di Chiarugi. Nella apparenza non è cambiato molto. Nella sostanza è stato fatto un salto enorme. Chiarugi dice: folle perché cronico. Kraepelin dice: cronico perché folle: demente precoce.
Dopo Kraepelin, Eugen Bleuler, nel 1911, sostiene testualmente: «L'osservazione che una malattia acuta può avere come conseguenza un danno permanente dell' organo colpito non ha trovato in nessun campo un significato così grande come in psichiatria. Le malattie «incurabili» riempiono da sempre i nostri asili. Così col tempo è andata formulandosi una delle domande più roventi della psichiatria: quali delle forme acute confluiscono in stati finali incurabili e quali no?»9. Non si parla di cronicità in modo generico, come a suo tempo Chiarugi. Si parla di acuzie e di cronicità, in senso strettamente medico. I termini riecheggiano quelli di infiammazione, restitutio ad integrum, degenerazione, correntemente usati in medicina. L'atteggiamento è pessimistico. Ancora Eugen Bleuler: «Non ho mai dimesso uno schizofrenico nel quale io non potessi riscontrare ancora chiari segni della malattia e sono ben pochi i casi in cui quei segni, in virtù, debbono essere (accuratamente) cercati»10. Il concetto di endogenità influenza non poco anche Freud. Siamo nel 1914, e si tratta dell’Introduzione al Narcisismo: « ... Si trattò di fare collimare ciò che sapevamo della dementia-praecox (Kraepelin) o della schizofrenia (Bleuler) con le premesse della teoria della libido. I malati di questo tipo, che ho proposto di definire parafrenici, presentano due tratti caratteristici fondamentali: il delirio di grandezza e il distacco del loro interesse da persone e cose del mondo esterno. In virtù di quest’ultimo mutamento essi si sottraggono all'influsso della psicanalisi e diventano così inaccessibili agli sforzi che facciamo per curarli»11.
Questa affermazione di Freud influenzerà per almeno trent’anni l'atteggiamento degli psicanalisti nei confronti della possibilità di una psicoterapia delle psicosi.
La psicanalisi, quindi, ai neurotici, l'ospedale psichiatrico agli psicotici. Intanto l'unica cosa che si sa sulle psicosi endogene è che sono, appunto, endogene. Manfred Bleuler: «Quando oggi si parla di disturbi mentali «endogeni», si intende, prima di tutto, malattie mentali di origine sconosciuta ... »12. K. Jaspers, sullo stesso tema: «Il concetto di endogenità, usato più spesso di quanto dovrebbe avvenire in senso del tutto generico, non è altro che un velo che nasconde il nostro non sapere»13. E tuttavia la psichiatria si comporta come se sapesse; o come se fosse in attesa di sapere definitivamente. Ancora Jaspers, pur criticando il materialismo manicheo della psichiatria, dirà: «La grande importanza pratica della acquisizione di conoscenze dei meccanismi somatici che, con tutta probabilità e soli permetteranno forse in futuro una influenza terapeutica coronata da successo - una guarigione radicale ... »14.
Al come se clinico, origine della prima cronificazione, farà seguito il come se terapeutico, sommandosi come rinforzo al processo in precedenza descritto. Non è nostra intenzione polemizzare qui sul fondamento dei trattamenti somatici in psichiatria; né intendiamo discutere il loro effetto sul sintomo. Ciò che ci interessa è il meccanismo di rinforzo del processo di cronificazione attraverso il silenziamento sintomatologico. Vogliamo dire che le tecniche di silenziamento sintomatologico - tutte le terapie somatiche lo sono - fanno parte di un circuito che si autoalimenta, nel senso che gli interventi «terapeutici» danno conferma di una nosografia che è - certamente in gran parte - frutto di un processo ambientale di cronificazione. I risultati degli interventi vengono riferiti a pazienti acuti, subacuti, cronici, visti in seguito come guariti, migliorati, invariati, attraverso accurate ricerche statistiche. E si tratta sempre, tuttavia, di malattie di cui non sappiamo nulla e di condizionamenti ambientali negativi di cui si riconosce sempre più l'influenza; e di «terapie» prive di fondamento scientifico ed il cui meccanismo di azione rimane nel buio. Per concludere: abbiamo visto che la patogenesi e il decorso di malattie delle quali ignoriamo l'origine vengono influenzati dall’atteggiamento di chi diagnostica e cura; e dal messaggio che dalla psichiatria viene trasmesso alla società. La diagnosi, la prognosi, le terapie hanno grande importanza per quello che rappresentano nella mente degli operatori e per quello che riflettono nella mente degli assistiti, della famiglie, delle persone che si ammalano. La maggior parte degli interventi psichiatrici rafforza il «fondamento» della psichiatria riproponendo la malattia mentale come un dato e non come un prodotto. Tutto ciò favorisce e determina la cronificazione dei pazienti. La prevenzione della cronificazione è dipendente dal1’atteggiamento critico dello psichiatra che ha coscienza della propria contraddizione: egli sa, da un lato, che sa ben poco; e, dall'altro, che può fare a meno di servirsi di interventi «terapeutici» pur nella coscienza del precario fondamento degli interventi stessi. In altre parole: non abbiamo bisogno di una psichiatria che faccia sempre meglio, ma di una psichiatria che si faccia continuamente domande sul senso del fare.
SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PSICHIATRICI
«Paese Sera» del 17 ottobre 1981 anticipa la pubblicazione dell’intervento di Michele Risso sugli operatori psichiatrici nella società di oggi, apparso poi nel volume «Psicologia e psichiatria», a cura di Vincenzo Caretti e Giovanni P. Lombardo, edito da Bulzoni.
Michele Risso
Nell'Enciclopedia Einaudi, alla voce «Culturale materiale», si legge: «il progresso materiale è forse l'unico progresso certo. Se non c'è il minimo dubbio sul fatto che l'uomo abbia accresciuto la sua padronanza sul mondo ( ... ), non è certo che abbia aumentato la sua padronanza su se stesso» (Richard Boucaille e Jean Marie Pesez: Enciclopedia Einaudi, vol. 4, pag. 301). Per ciò che riguarda la padronanza su noi stessi, l'unica cosa certa è che questa comporta prezzi altissimi. In compenso, non c'è dubbio che la conoscenza che l'essere umano ha di sé e dell'altro si è approfondita e che aumentato è il bagaglio di conoscenze nel campo delle cosiddette scienze umane. Ciò purtroppo non corrisponde ad una crescita del benessere psichico soggettivo e collettivo, al contrario; ma questo non significa, necessariamente - come alcuni in modo sbrigativo vorrebbero - che le conoscenze di cui si parla siano infondate o campate in aria; può significare, tuttavia, che il loro accumularsi vada di pari passo con la presa di coscienza dell'aumento del disagio che tutti ci riguarda; e che, forse, da questo disagio in buona parte derivi. Interpretare un disagio non vuol dire, purtroppo, avere in mano la ricetta della cura. Quello che noi sappiamo non può nulla non dico per sanare, ma per arginare il crescente malessere in cui viviamo
Tuttavia, nel nostro agire - e parlo qui di un agire specifico, come psichiatri, psicoterapeuti, psicologi - dobbiamo, lo sottolineo, fare riferimento a conoscenze che hanno un risvolto operativo, che vengono tradotte in tecniche di intervento, in pratiche di cura (inteso, quest’ultimo termine, come tendenza, non come escatologica aspettativa).
Ora, la domanda: quale cura, se il disagio di fondo rimane immutato? Quale intervento se la ben nota qualità dei rapporti tra gli esseri umani ne esce intoccata? Non si elimina il sospetto che le conoscenze si accumulino e si affastellino indipendentemente dalla fondatezza del messaggio scientifico originario, ma secondo il loro aderire ad una logica che le vuole applicate come provvedimenti che finiscono per mantenere inalterate le cose fornendone diversificate spiegazioni, interpretazioni, giustificazioni. La applicazione delle tecniche appare, così, neutrale in quanto il suo effetto rimane del tutto neutro per ciò che riguarda i mutamenti essenziali (e non di superficie) a livello individuale e collettivo.
Chi ha avuto la spregiudicatezza di affrontare il problema dell'effetto a distanza dell' applicazione di varie tecniche di intervento in psicoterapia è giunto a conclusioni abbastanza sconcertanti: sembra che, quanto ai risultati, le tecniche usate abbiano carattere di intercambiabilità. Questo non vuol dire che, per quanto riguarda le discipline che sottendono le tecniche, «una valga l'altra»; ma che l'intervento tecnico incide probabilmente molto meno di quanto si pensi sulla evoluzione del male; essendo quest’ultima influenzata al contrario e molto di più dal rapporto che ha l'intervento tecnico con il contesto dei valori e delle regole sociali in cui esso si situa.
L'evoluzione del malessere - il suo aumentare o diminuire - dipende quindi non ultimo dal potere reale che hanno le conoscenze acquisite nel campo delle scienze umane nei confronti del potere precostituito che le vuole al proprio servizio. Ora, il potere conferito alle persone che detengono queste conoscenze è scarso e consiste, soprattutto, nell’attuarsi di quella trasmissione verticale delle conoscenze stesse, in ragione della logica dei ruoli.
Tale trasmissione, poi, non avviene nella pratica del lavoro quotidiano - tale caso non sarebbe più verticale - ma in sedi che sono lontane dai servizi in cui questo lavoro si confronta con l'urgenza dei bisogni. Le tecniche, calate dall'alto nella realtà dei servizi, rischiano di indurre bisogni e di non rispondere alla domanda di cura. Prova di questo può essere l'indagine multicentrica condotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che suggerisce la conclusione seguente: il tipo di risposta dei servizi non solo determina la domanda degli utenti, ma può favorire processi di cronificazione della malattia che si vuole curare. In altri termini: la distorta risposta dei servizi traduce il disagio in malattia e coagula la condizione di sofferenza in uno stato definitivo che richiede non più cura ma assistenza, non più intervento preventivo ma gestione routinaria.
Ancora una volta la domanda: quale cultura e per quali operatori. La situazione italiana si trova, mi sembra, su un crinale abbastanza rischioso. Da un lato, le esperienze di lotta ai manicomi - una pratica che ha avuto grande importanza politica e sociale - mostrano appena ora il loro peso come rottura di paradigmi della tradizionale psichiatria, come messa in discussione del concetto di decorso e di cronicità delle malattie mentali, pur non formulando teorie di interpretazione alternativa. Inoltre esse possono essere applicate solo in parte e con difficoltà nel nuovo lavoro sul territorio e non sono in grado di rispondere da sole alle domande urgenti di cura e di presa in carico che non vengono più orientate verso il manicomio, come in precedenza.
D'altra parte queste esperienze rifiutano un intervento tecnico codificato da calarsi acriticamente nei servizi; tale intervento si propone tuttavia come ineliminabile (il che non vuol dire che debba essere paracadutato verticalmente nei servizi).
C'è quindi il pericolo di una dicotomia: 1'angolo della forbice tende ad allargarsi. Da un lato, servizi condotti secondo criteri non codificabili, dove l'inventiva ha ormai poco spazio e la creatività si scontra con gravi problemi assistenziali e di gestione; dall'altro luoghi di formazione teorica degli operatori che forniscono conoscenze disarticolate da una concreta pratica di lavoro.
Il problema da risolvere è, mi sembra, quello della saldatura - non dell' accostamento - tra servizi e luoghi di formazione degli operatori. Come questo sia possibile non so, né ho l'autorità né la competenza per dire come. Mi sembra inoltre che sia inevitabile partire dai servizi e dalla pratica di lavoro in essi svolta. Se è vero - ed è ormai provato - che la risposta dei servizi condiziona non solo la domanda degli utenti ma il decorso di quel disagio che l'utente presenta ai luoghi deputati alla prevenzione ed alla cura, appare inutile e dannoso l'immettere dall'alto nei servizi moderne tecniche di intervento e senza un piano organizzato di verifica critica.
D'altra parte, è necessaria una formazione teorica degli operatori che non sia una trasmissione verticale dì «nuove» conoscenze da tradursi in tecniche. Sinora, nel mondo delle sincronie convulse, dei «valori» che si intrecciano nella loro interscambiabilità, troppo poco spazio ha avuto la attenzione diacronica e la fatica a questa connessa. E' importante prima di tutto sapere come e dove e quando nasce un messaggio scientifico; in seguito, come «correttamente» lo si può applicare in campo tecnico.
Paradossalmente, il sapere non porta all'operare immediato, ma ad una critica dell'operare stesso. Se ci si prende la briga di osservare le cose da vicino, ci si rende conto che il nuovo riluce molto meno di quanto vorrebbero i predicatori della novella. E che il vecchio è infinitamente tenace e radicato proprio negli strati sottostanti la coscienza di chi rappresenta, appunto, le «ultime novità», con fiducia nelle magnifiche sorti e progressive.
Mentre parliamo qui di formazione di operatori - riprendendo un tema che fu ampiamente trattato a Gorizia nel 1974, nel convegno «La pratica della follia» i cui atti sarebbe forse opportuno rileggere; e a Trieste nel convegno del Reseau del ‘77, per non dire di altre sedi come Pordenone, Perugia, Bologna, recentissimamente -, a S. Maria della Pietà, a distanza di quasi tre anni dalla legge 180, ci sono 1100 malati, dei quali la percentuale di «ospiti» è del tutto esigua (poco più di 50) con circa 500 infermieri, 100 ausiliari, una trentina di medici immersi in una situazione che non presenta accenni al cambiamento; molti dei malati sono ancora legati ai letti, sembra che la loro cura e la loro liberazione siano eventi che appartengono ad un improbabile futuro. Allora: quale formazione, di quali operatori? Che cosa fa, che cosa non fa l'Ente locale? Che cosa esita a fare, che cosa si rifiuta di fare? Quali le responsabilità, le inspiegabili inerzie?
Inoltre: ormai, da tutte le parti si è concordi nel dire che i problemi dello specifico sono secondari ai problemi sociali e di struttura; che i nodi, in altri termini, stanno altrove. E tuttavia si assiste a un fenomeno strano: che lo specifico apparente, diversificato cavallo di Troia, entra nei servizi secondo una strana logica: l'apprendimento delle tecniche - non delle conoscenze -, l'adesione alle varie ideologie sociopolitiche, psicanalitiche, relazionali, comportamentali, ecc., sta diventando elemento qualificante per chi voglia trovare accesso al lavoro più o meno retribuito nei servizi. La mano sinistra, volta alla critica del sociale, ignora ciò che fa la destra, intenta ad una «formazione» di operatori che sarebbero forse da discutere. Certo, questo non vuol dire partecipazione delle conoscenze (l'espressione suona addirittura vetusta), ma ridistribuzione del potere, relativo, appunto, alla formazione cosiddetta. Potere limitato, a mio avviso miope, anche se nella apparenza gratificante.
DA ERNESTO DE MARTINO A MICHELE RISSO
NOTA SU SORTILEGIO E DELIRIO DI RISSO E BÖKER
(Michele Risso e Wolfgang Böker, Sortilegio e Delirio. Psicopatologia dell’emigrazione in prospettiva transculturale, Liguori, Napoli, 1992)
di Vittorio Lanternari
L'eccezionale valore pionieristico di questo libro di Risso e Böker, che appare in Italia con un ritardo di quasi 30 anni (l'edizione originale in tedesco, praticamente rimasta ignorata da noi, è del 1964) s’impone non soltanto sul piano della scienza psichiatrica ma anche rispetto ai modelli epistemologici prevalenti in generale nella scienza dell'uomo, e in particolare l'antropologia, in quanto disciplina volta allo studio dei processi simbolici e delle rappresentazioni collettive proprie dei soggetti, delle situazioni e dei popoli più vari. Il libro presenta temi e problemi che solo più tardi avrebbero trovato da noi uno sviluppo autonomo coerente e sistematico. Vi sono implicati, su un piano speculativo e applicativo estremamente impegnato, problemi del conoscere, intendere, valutare le reazioni psico comportamentali dell'individuo nei suoi rapporti col mondo e con le persone: reazioni correlate ai condizionamenti provenienti dal suo ambiente sociale e culturale d'origine. Qui per la prima volta viene messa in questione in modo innovatore, in base ad una raccolta di casi umani analizzati in ospedale, su un piano anamnestico e clinico, dall’equipe psichiatrica dei due autori, una serie di presupposti mentali e categorie nosologiche vigenti nella scienza medico-psichiatrica, ma anche sconfinate nell'abito mentale corrente della nostra cultura ufficiale. La nozione di «delirio», come quella di «malattia mentale» risultano essere messe implicitamente in discussione. Infatti Risso e Böker pongono qui le basi di quella nuova «psichiatria transculturale» che Risso stesso preannuncia esplicitamente in termini precisi, e che oggi ormai - dopo 30 anni uscita dallo stadio embrionale -, s'è posta al centro dei dibattiti nel campo delle più aggiornate discipline medico-psichiatriche.
Ma conviene subito sottolineare che lo studio di Risso-Böker assume un significato particolarmente prezioso, nuovo e fecondo per noi oggi, se pensiamo al fenomeno sopravvenuto proprio in questi anni, con prevedibili sviluppi via via più drammatici e allarmanti per le reazioni destate nei vari paesi europei, dell' ondata migratoria dai paesi del Terzo Mondo.
È proprio sulla situazione degli emigrati in terra straniera, sul loro vissuto che questo libro di Risso-Böker - come pure avviene nell' altro più recente di Risso e Delia Frigessi Castelnuovo, A mezza parete (Einaudi 1982) - applica la sua lente d'ingrandimento, o piuttosto il suo microscopio, e ne scova pieghe psichiche e culturali riposte, inconsce e inconfessate: pieghe dalle quali si scatenano incontrollate disfunzioni, reazioni psicofisiche, conflitti interiori e sofferenze tali che compromettono pericolosamente l'equilibrio interiore ed esistenziale del soggetto umano. Le conseguenze rivestono caratteri tali da poter coinvolgere i rapporti individuo/società, e dunque da investire interessi d'ordine sociale. Così, sul dramma di gente che proviene da ambienti rurali poveri, di sottosviluppo, di cultura arretrata, di lingua diversa, e arriva in un paese di struttura industriale avanzata, messa alle prese con problemi pratici di lavoro, accoglimento e comunicazione, il libro fa una luce nuova e scopre uno spettro di conflittualità interiori, di sofferenze segrete che nessuno da noi aveva prima enucleato e reso conoscibili al pubblico, o agli eventuali operatori sociali. […]
Oggi questo libro si presenta quasi come guida teorica e metodologica, come modello-paradigma di orientamento etico, professionale, umano di fronte alla responsabilità, che incombe su noi, di saper gestire senza colpevole ignoranza, senza omissioni, miscomprensioni e infingarda trascuratezza, il compito di operare in modo equo per la sistemazione di immigrati dal Terzo Mondo o dall'Est. Oggi si tratta di rispondere in modi positivi alle esigenze vitali che toccano, oltre che l'ordine dei problemi pratici, socio-economici, politico-giuridici ecc., 1'ordine dei problemi psicologici, di mutua conoscenza a livello culturale profondo.
( ... ) Ma a sua volta il bisogno di amplificare il quadro dei presupposti epistemologici inerenti alla scienza psichiatrica ortodossa, è stato promosso, nella riflessione dei due studiosi-psichiatri, da quel medesimo ordine di problemi di fronte ai quali s'era trovato Ernesto De Martino. Era il problema della «fascinazione» magica, nel suo studio concernente gli aspetti di persistenze magiche proprie del folklore lucano; ovvero, pochi anni dopo, sarebbe stato il tema del tarantismo nel Salento: entrambi i fenomeni carichi di inquietante ambiguità semantica: fra natura e cultura, tra biologia e mito il tarantismo, fra nonsenso alienato e logica simbolizzante, la fascinazione. Risso ben conosceva De Martino, il cui libro Sud e magia era uscito nel 1959, La terra del Rimorso nel 1961. A proposito, poi, de La fine del mondo, particolarmente nell'amplissima sezione etnopsichiatrica contenutavi, più tardi Risso ebbe a dire proprio a me, che quel libro per lui rappresentava il miglior «manuale» di psichiatria esistente.
( ... ) Dunque da un lato De Martino da antropologo si apriva a problematiche d’ordine originariamente psichiatrico, illuminandole di nuova luce attraverso la rivisitazione critica dei modelli teorici e cognitivi tradizionali, sotto l'effetto della comparazione interculturale e della contestualizzazione olistica, critica, dei fenomeni culturali analizzati. Risso viceversa si muove da psichiatra, per aprirsi al principio originariamente «antropologico» della contestualizzazione socio-culturale e dell’allargamento della visuale diagnostica già limitata ai problemi e ai casi della società borghese occidentale. Perciò dedica i primi capitoli del libro a fare un quadro della cultura e delle condizioni sociali del Mezzogiorno, secondo il disegno allora fornito dai lavori demartiniani, di Carlo Levi, di Danilo Dolci.
Dal sodalizio culturale con De Martino - troncato presto dalla morte di quest’ultimo nel 1965 - Risso riceveva un incoraggiamento alla problematizzazione delle categorie gnoseologiche, diagnostiche correnti nell’ambito della scienza occidentale circa fatti psichici e psicopatologici. Il suo interesse si orientava fin da principio verso culture e ceti emarginati, come dimostrano vari suoi contributi, oltre al lavoro sullo «stregamento» tra emigrati nostri in Svizzera.
SORTILEGIO E DELIRIO
APPENDICE 2
(Michele Risso e Wolfgang Böker, Sortilegio e Delirio. Psicopatologia dell’emigrazione in prospettiva transculturale, Liguori, Napoli, 1992)
Michele Risso
«Gli uomini badano, in genere, soprattutto a che cosa si dice. Così accade spesso che analista e paziente, una volta chiarito ciò che a vicenda dicono, credono di comunicare. Può darsi che comunichino, ma probabilmente non attraverso ciò che dicono». (da una lettera di un paziente)
Noi sappiamo sempre di più «di che cosa si tratta», sempre meglio «come si fa»: purtroppo non sappiamo con altrettanta sicurezza perché i nostri pazienti guariscono, o migliorano, o non guariscono.
Chi abbia conoscenza di interventi psicoterapeutici nel mondo magico sa che, in buona parte di casi, le parole, le formule espresse da uno stregone, da un guaritore non vengono comprese razionalmente dal paziente e tuttavia hanno su di lui un’azione che non può semplicisticamente essere definita solo come «suggestiva».
A questo punto ci si potrebbe domandare se non succede qualcosa di analogo - mi sia concessa questa eretica ipotesi - in psicoanalisi. È d'altra parte evidente che gli psicoterapeuti, soprattutto nella cura di stati psicotici, entrano con i loro pazienti in un mondo in cui le parole sono insufficienti ed inadeguate - e tuttavia debbono essere usate - e le sensazioni ed i ricordi rimangono confusi. È il mondo dell’angoscia, dell’estasi, della carenza, tanto più significativo quanto meno il paziente può comunicarne verbalmente ed il terapeuta interpretare.
Mi sembra discutibile, a questo punto, che lo psicoanalista abbia il diritto di usare la sua martellante, schematica interpretazione; che potrà forse riuscire a persuadere il paziente, ma che in prima linea serve a rassicurare il terapeuta, per dire a se stesso che conosce il preciso significato di ciò che, da parte del malato, gli viene incontro come angosciosa minaccia che vorrebbe respingere o come insistente richiesta che non può essere soddisfatta. Minaccia e richiesta rivestite inadeguatamente di espressioni verbali. Bisognerebbe, a mio avviso, in questa situazione, rispondere in un modo che corrisponda alla sensibilità del paziente, anche se l'espressione verbale del terapeuta rimane altrettanto incompleta e frammentaria.
Credo che la consapevolezza di questo limite e della necessità di verbalizzare, da entrambe le parti, qualcosa che precede il mondo della parola, costituisca la base di quella comunicazione che, in mancanza di un’adeguata possibilità di espressione verbale, nasce nell'ambito preverbale e rimane essenzialmente preverbale. Su questa comunicazione si fonda, senza dubbio, un sostanziale valore terapeutico; poiché se paziente e terapeuta accettano questa funzione sono molto più attenti al contenuto affettivo della parola, che non al suo significato rigorosamente e spesso miseramente formale.
Questa osservazione non vuole essere interpretata come una romantica attrazione per l'irrazionale, ma sottolinea la coscienza di trovarsi di fronte ad un confine, la cui consapevolezza non pone solo un limite ma schiude, anche, prospettive alle quali il nostro atteggiamento scientifico non riesce ad avvicinarsi.
A MEZZA PARETE
(Delia Frigessi Castelnuovo e Michele Rissa, A mezza parete, Einaudi. Torino, 1982)
Michele Risso e Delia Frigessi Castelnuovo
L'etnocentrismo psichiatrico proietta sul mondo circostante il proprio sapere che, invece di essere messo in discussione, fa in modo di trovare conferma, attraverso una scelta accurata degli elementi, della fondatezza del sapere stesso e della sua parzialità. Il problema della cultura egocentrica («lei è completamente diverso da me ma io le perdono») è messo in nesso stretto anche con quello della precarietà della diagnosi e con l'ideologia nosografia che nasconde il non sapere di chi esamina.
Molto spesso la diagnosi viene posta da un medico che non conosce a fondo la lingua del migrante e tuttavia, per evidenti ragioni, deve esprimere un giudizio sul suo stato. Quando, per fare un esempio non raro, questo medico pone una diagnosi di schizofrenia - a parte la fondatezza di una tale espressione diagnostica - c'è il rischio di porre un timbro nosografico sbrigativo a un paziente in una condizione psichica particolare di sofferenza. Timbro che ha poi la sua influenza e sui successivi ricoveri e sull'immagine che il paziente riceve di sé. In modo simile agisce il criterio con cui gli psichiatri giudicano l'intelligenza degli emigrati.
( ... ) In realtà chi arriva all’osservazione psichiatrica, emigrato o no, è un individuo che presenta prima di tutto alterazioni del comportamento, e le alterazioni sono riferite a una norma sociale e non a una salute individuale.
Chi arriva all'osservazione psichiatrica è prima di tutto una persona che ha infranto una norma. E’ appunto nell'ospedale psichiatrico che la devianza diventa sintomo, il sintomo segno di malattia, il segno di malattia diventa mancanza di salute. Ad illustrare una particolare condizione, nel nostro caso quella dell'emigrato, si potrà trarre materiale essenzialmente antropologico e sociologico dalla casistica psichiatrica.
Perché ciò che conta è come ci si ammala, come anche qui un disagio viene tradotto in malattia.
( ... ) I migranti classificati come malati mentali sono solo i testimoni più visibili di una condizione che andrebbe trasformata nelle sue radici. La psicopatologia e l'epidemiologia dell'emigrazione si riferiscono a condizioni «altre» che si trovano al di sotto della punta visibile dell’iceberg e riverberano un disagio, una sofferenza, una tematica che appartengono a tutti coloro che debbono lasciare la casa, la terra d'origine, a tutti quelli che sono costretti a emigrare, non solo a coloro che giungono all’osservazione psichiatrica.
TERAPEUTA E POLITICO, PSICOANALISTA E ANTIPSICHIATRA,
MICHELE RISSO,
COMPAGNO DI BASAGLIA NELLA CONTRADDIZIONE
(il manifesto, 11 giugno 1981)
Giorgio Bignami
«Senza speranza non è la realtà ma il sapere che - nel simbolo fantastico o matematico - si appropria la realtà come schema e così la perpetua». Con queste parole di Horkheimer e di Adorno, Franca e Franco Basaglia avevano introdotto la voce Follia/Delirio per l'Enciclopedia Einaudi. Con questa stessa citazione Michele Risso aveva voluto aprire un suo ultimo scritto sul modo in cui la scienza psichiatrica costringe l'ammalato mentale alla cronicità, annotando per ulteriore chiarezza: «In effetti, nel linguaggio che la ragione, attraverso la psichiatria, ha imposto alla follia l’ “ostinazione” del delirio non ha avuto che un nome: cronicità».
Questa la conclusione, provvisoria quanto significativa, del lungo itinerario di Michele Risso attraverso la sofferenza degli uomini; cioè di un viaggio ben al di là dei confini della psichiatria vecchia e nuova, nel tentativo di liberare la realtà dalle «maglie di un sapere che in qualche modo la “inchioda” per poterla assumere come oggetto di un discorso».
Il protagonista appena scomparso sapeva che questa sua ricerca - una ricerca senza fine, che nessuno può pretendere di portare a termine - comunque non poteva svolgersi se non attraverso il contatto quotidiano e drammatico con ciascuna delle molte facce della sofferenza; se non attraverso il rapporto difficile e problematico con ciascuna delle molte proposte per conoscere e classificare la sofferenza stessa, per curarla e controllarla.
Fuggito negli anni cinquanta dalla morta palude della medicina e della psichiatria italiana, Michele Risso aveva trovato in Svizzera uno spazio di lavoro contraddittorio ma stimolante. Immigrato tra gli immigrati, aveva dovuto iniziare la carriera dalla gavetta, cioè come dispensatore di terapie di shock nell'apposito reparto di una clinica psichiatrica universitaria (vedi Sapere, marzo 1980). Attraverso questo lavoro, e dovendo occuparsi anche di altri aspetti della psichiatria organicista - è ormai classica una sua analisi critica delle conseguenze della leucotomia, cioè della «cura» chirurgica della follia - era potuto andare sino in fondo all'arbitrarietà dei «modelli» della psichiatria biologica di stampo positivistico e alla falsità dei «risultati» su cui si sostengono le relative pratiche terapeutiche.
Ma qui, anche, occupandosi degli immigrati italiani, aiutandoli nella loro sofferenza, sostenendoli con le sue relazioni peritali nelle controversie sulle invalidità da lavoro, ricollegando le manifestazioni del loro disturbo psichico al cozzo tra schemi culturali molto diversi - quelli della comunità d'origine e quelli incontrati nel luogo della deportazione - aveva scoperto la necessità di una dimensione ben più ampia di quella della psichiatria. Così dalla monumentale indagine sui deliri di affatturazione negli italiani in Svizzera (Verhexungswahn, Karger, Basel, 1964) allo studio condotto con Giovanni Jervis sull'argismo sardo (vedi I rituali dell’Argia, a cura di C. Gallini, Cedam, Padova); dal lavoro sulla comunità terapeutica magico-religiosa di Serradarce di Campagna (Misère, Magie e Psychothérapie; in Confinia Psichiatrica, vol. 14, n. 2, p. l08, 1971) sino all'importante opera di prossima pubblicazione, sui rapporti tra emigrazione e disturbi mentali si snoda un filo analitico di rigorosa, demartiniana scientificità, allo stesso tempo vibrante di commossa partecipazione umana alle vicende degli oppressi, al loro proiettarsi fuori della storia nell’estremo tentativo di sottrarsi a una sofferenza troppo grande.
Questi anni prima del definitivo ritorno in Italia (1963) sono anche gli anni di un altro incontro determinante per Michele Risso, quello con la psicoanalisi. Della validità scientifica del metodo psicoanalitico sfrondato delle sue assolutizzazioni egli resterà, sino all’ultimo, strenuo e scomodo sostenitore; ma delle mistificazioni della psicoanalisi, delle sue molte occasioni perdute, delle sue chiese, dei suoi sacerdoti e dei suoi adepti galleggianti in assenza di peso fuori della storia, sarà ancor più scomodo critico e accusatore («cane in chiesa» si autodefiniva a questo proposito). Negli ultimi tempi, quando già la malattia imponeva un estremo sforzo di chiarezza, questa accusa e questa critica si erano andate venando di comprensibile angoscia. Come pochi altri, infatti, Michele Risso poteva testimoniare per esperienza diretta come il crescente consumo di psicoanalisi - assieme ad altre scelte del postsessantotto - fosse un segno di sbando e di fuga di chi aveva creduto in «un’illusione, un sogno, un annuncio come se fosse nata la possibilità di vivere non più in uno spazio storico, ma in uno spazio finale».
Se il grande pubblico non può collegare il nome di Michele Risso alle vicende della lotta antiistituzionale, tuttavia per il riconoscimento di molti addetti ai lavori politici egli è stato uno dei grandi protagonisti dello scontro, incominciato con Gorizia. Poco dopo il ritorno in Italia aveva incontrato Franco Basaglia, e da allora i due uomini - pur così diversi, pur con opinioni non di rado disomogenee su aspetti importanti della gestione psichiatrica - non si erano più lasciati.
Anzi, agli intimi apparivano quasi cementati insieme, come siamesi costretti da necessaria vicinanza a continue verifiche e discussioni: l'uno, notoriamente, poco tenero verso la psicoanalisi e in genere verso qualsiasi sforzo di cura che in qualche modo potesse riallacciarsi al passato; l'altro, come si vedrà ancora più oltre, impegnato a percorrere un faticoso itinerario di affermazione-negazione delle eredità teoriche e pratiche.
Così, da Roma dove si era stabilito, Michele Risso aveva incominciato con l'andare a Gorizia, e poi in altre sedi dello scontro; insomma, dovunque vi fosse bisogno di una persona come lui, a verifica e a sostegno dell'impegno degli operatori dapprima tesi nello sforzo di rompere i vecchi schemi manicomiali, poi lanciati nelle prime esperienze in equipe nei nuovi servizi sul territorio. Esemplare sarà, sotto questo secondo aspetto, l'esperienza umbra di Città di Castello.
Questo lavoro, se da un lato gli faceva crescere intorno consenso, stima, affetto, dall'altra non poteva non generare acute tensioni. Come si è già accennato, la ricerca di Michele Risso non escludeva alcuno dei diversi aspetti della sofferenza. Così egli precorreva sviluppi non ancora attuabili nei nuovi servizi, attraverso una pratica professionale straordinariamente innovativa nella sua inevitabile (ma tutt’altro che assoluta) elitarietà. Alcuni «cardinali zelanti» - la definizione è del presidente de Brosses, nel suo celeberrimo capitolo sulla strumentalizzazione dell'ideologia ed è pesante; ma non se ne trova una più esatta - negando ogni valore e significato a tale sperimentazione che difficilmente si sarebbe potuta trasferire altrove, avevano deciso di non perdonare questo «peccato» contro lo Spirito santo dei nuovi tempi.
Ma Michele Risso, intransigente innanzi tutto con se stesso, andava ugualmente avanti per la sua strada non facile. Mentre approfondiva più acutamente di altri l'arbitrarietà dei diversi modelli scientifici e delle relative tecniche terapeutiche («tutte intercambiabili nell'ambito di un'ideologia data») allo stesso tempo sosteneva la necessità, per tutti gli operatori, di acquistare una conoscenza esaustiva dei filoni della psichiatria classica («nel suo sviluppo storico e nel suo linguaggio d'uso tuttora in vigore»). Sosteneva anche che tutti insieme si dovesse sperimentare rigorosamente una nuova prassi didattica, atta ad incrinare la «trasmissione verticale del sapere-potere» su cui arbitrariamente si fonda il «modello» di malattia e quindi l'intervento tecnico. Rifiutando di dire «come si dovrebbe fare» e «come si potrebbe fare meglio», spingeva se stesso e gli altri a chiedersi più insistentemente: «cosa significa quello che stiamo facendo». Considerava cioè necessaria, anzi irrinunciabile, pena il fallimento, una «lunga marcia attraverso le tecniche di intervento specifico - dalla psicofarmacologia alla psicoterapia - non per apprenderle e praticarle senza alcuna critica, ma per sapere da dove vengono, quale è la loro utilità, il loro limite, il loro danno: e dove ci possono condurre».
E qui, soprattutto negli ultimi tempi, il discorso diventava, a tratti, un discorso duro. Certo, diceva Michele Risso, «siamo su un terreno minato ... nessuno di noi può distinguere il confine tra cura e controllo». Ma ancora più rischioso può essere il voler cercare a tutti i costi, con chi sta annegando nella sofferenza, «le radici reali del disagio», imponendo un’ennesima ideologia al posto di quella che si vuole contro battere, inevitabilmente ripercorrendo in maniera acritica, in parallelo all'indottrinamento, a un qualsiasi intervento tecnico-terapeutico male digerito. Insomma «a Trieste si diceva giustamente che la libertà è terapeutica» (infatti Michele Risso è stato tra i più appassionati e agguerriti sostenitori e poi difensori della legge 180). «Certamente è così, ma dovremmo sapere meglio perché questo è vero; altrimenti confonderemo l'effetto terapeutico della libertà per un essere umano che sta attraversando una profonda crisi e la Libertà che è, certamente, “terapeutica” per tutti…
Diciamo allora che terapeutica può essere “la libertà” di attraversare il proprio delirio accompagnato da persone in grado di distinguere la calce dalla farina, lo zucchero dall'eroina, e l'acqua dall' acquavite».
(. .. ) A troppo breve distanza dal rito dell' anno scorso a Venezia, una settimana fa a Bracciano, dopo l'ultima testimonianza di Franca Ongaro Basaglia, è scesa su Michele Risso la terra del luogo che aveva ormai scelto come patria, vincendo l'attaccamento pur profondo per quella dove era nato, in Piemonte. Dopo l'esperienza fatta da ragazzo, quando era fortuitamente scampato alla strage di Boves, ogni tappa del suo viaggio - sino all'ultimo anno di lavoro e insieme di dura lotta contro la malattia - appare oggi come segnata da una profonda necessità. Come pochi, Michele Risso, riconciliando teoria e prassi, ha vissuto sino in fondo 1'aforisma di Theodor Adorno, il filosofo in cui meglio che in ogni altro si ritrovava con la giusta dose di disagio: «Uno stato d'animo intransigente, però, è l’opposto della selvatichezza, dello spirito da neofita e degli “spazi non capitalistici”. Esso presuppone e esperienza, memoria storica, nervosità di pensiero e soprattutto una buona dose di disgusto. Sempre si è potuto ogni qualvolta osservare come coloro che si inserivano giovanissimi e ingenui nei gruppi radicali disertavano non appena accortisi della forza della tradizione. Per odiare davvero la tradizione, bisogna possederla in se stessi».
COSA CI HA INSEGNATO MICHELE RISSO
ABBATTERE I MURI DEL SILENZIO, ECCO IL MESTIERE DI VIVERE
(L'Unità, 5 giugno 1981)
Pietro Ingrao
C’è una sorta di incredulità di fronte a una vita ricca che si spezza proprio nel suo fiore, mentre sembra che stia per esprimere tante potenzialità. E Michele Risso dava al massimo l'immagine di una vitalità intensa, direi: di una tensione verso la vita, come di una continua ricerca delle molte forme della vita, come un andarle a ritrovare dove altri vedevano solo esistenze crollate, rami secchi.
«Psicoterapeuta» è una parola che suona - insieme - astrusa e ambiziosa; può sembrare persino presuntuosa. Essa indica il «mestiere» di Michele Risso; e forse serve a sottolineare quel suo impegno attivo anche di fronte a «casi», a persone, a vicende umane estremamente complessi, quella sua volontà quasi disperata di «intervenire», anche dove la battaglia sembrava perduta, che hanno contrassegnato la sua specifica presenza nel gruppo di psicanalisti e di psichiatri, dentro il quale lavorò, e che a me sembrava una sua straordinaria volontà di comunicazione. Eppure a me riesce difficile chiudere in quella parola di gergo tutta la «curiosità» (forse è un termine sbagliato, ma non so adoperarne un altro), tutta la volontà di scoprire gli «altri» oltre le caselle consuete, tutta quell’apertura verso la vita, anche nelle sue forme più tormentate e rotte, che mi sembrava di cogliere nell'opera e nella battaglia di uno scienziato come Risso. Mi sembrava uno che andasse alla ricerca di identità individuali, come di luoghi, sentieri, forze, la cui ricchezza e anche originalità fosse ignorata, ferita, sommersa. Quando si parlava con lui mi sembrava sempre teso a questa scoperta, come se dicesse: guarda bene, guardiamo a fondo.
Ecco allora un senso di incredulità di fronte alla malattia e alla morte che troncano un percorso così denso di vita, in fondo: di amore alla vita, di estrema fiducia nella vita. Una rottura esterna, oscura, di cui non ci si dà ragione; per cui al dolore si unisce un senso di frustrazione, di casualità non dominabile; e non si è sicuri se così pretendiamo troppo (cioè chiediamo garanzie e sicurezze impossibili per noi stessi, per la condizione umana) o se ci sembra di aver fatto troppo poco (quasi un rimorso anche personale per l'aiuto che non abbiamo saputo dare a quella tensione vitale che viene troncata).
Ma si può ragionare anche in altro modo. Michele Risso e Franco Basaglia e altri del gruppo che ha condotto la battaglia per una nuova psichiatria, hanno schiodato vecchi e pesanti diaframmi che bloccavano le nostre menti sui temi essenziali riguardanti la soggettività individuale, il rapporto fra di essa e il farsi delle istituzioni, e quindi la nozione stessa moderna di soggettività e di libertà. Non si è trattato solo delle porte dei manicomi, e di chi vi stava chiuso dentro. Questi uomini hanno aperto finestre anche a noi, e noi abbiamo cominciato a vedere cose che non vedevamo: su determinate istituzioni, e sulle regole che sono la trama esplicita (o nascosta) di tanti nostri comportamenti.
Altri potrà dire, con competenza che io non ho, quali sono state le ascendenze, i cammini, e anche difficoltà e i limiti attraverso cui Risso, Basaglia e altri hanno abituato i nostri occhi a vedere in modo diverso nostri simili, e quindi anche dentro di noi. Io annoto qui il fatto; qualcosa che è avvenuto. Incontrando oggi altri, persone, vita, storie soggettive, noi guardiamo tutto ciò non più come prima: nel senso che il nostro orizzonte si è allargato; e si intravedono anche possibilità, ricchezze, creatività, dove prima vedevamo solo l'assurdo, il disfacimento, in fondo; la morte.
È possibile che la lingua nuova non sia ancora tutta limpida. Ma sono cambiate alcune cose nel nostro vocabolario. Di fronte alla caducità effimera di altre vicende, cose, gesti, parole, usualmente vengono definiti «fatti», e che trovano spazio e onore nelle cronache correnti, ecco innovazioni vere, forti, che hanno agito nel profondo: nel profondo anche di molti che non conoscono il nome di Risso e che forse sono stati toccati solo di riflesso dall' onda nuova. Queste cose si possono dire con orgoglio, pensando all’opera e alla battaglia di uomini come Michele Risso. Parliamo di radici nuove, che non sarà facile a nessuno distruggere. Allora anche la rottura improvvisa e immatura della vita può essere vista come la sfida affrontata per allargare la visuale, per pulire e sgomberare gli occhi, per imparare non solo a capire sofferenze, ma a scoprire persone, forze in qualche modo: nuovi mondi.
Lo scenario consueto, che ci viene presentato ogni mattina da chi di dovere, dice molto poco di questi «fatti», a cui cerco di alludere; di queste innovazioni e aperture, di ciò che esse possono dare per capire il nostro tempo, e per fornire una risposta a questa domanda ansiosa che sempre più ci portiamo dentro: come comunicare. Comunicare, nel significato più largo, fecondo.
Ma è possibile parlare oggi di risorse, e quindi anche di avvenire di singoli e di collettività, senza discutere di questi temi, e di come si costituisce nei fondamenti, una cultura del domani? Oppure sarebbe vero che conta solo il gioco delle «logge»?
Sappiamo che non è per caso che certi riflettori ci mostrano oggi solo certi scenari e non altri. C'è una lotta. Bisogna allora che si allarghino e si moltiplichino gli uomini «curiosi», amanti della vita, con occhi aperti, come è stato Michele Risso. E bisogna rispondere con la lotta e con il disprezzo a coloro che vorrebbero rimettere in piedi quelle mura fradice che per fortuna abbiamo cominciato ad abbattere. Come dispiace non aver saputo dire queste cose, in modo semplice, all'amico e compagno Michele Risso quando era vivo e probabilmente gli avrebbe dato ancora più forza nel suo lavoro!
BIBLIOGRAFIA PROVVISORIA DI MICHELE RISSO
A cura di Paolo Tranchina e Maria Pia Teodori
Senza data - Vasta indagine sulla statistica e la casistica di 709 emigrati italiani ricoverati tra il 1946 e il 1960 negli ospedali psichiatrici della Svizzera Tedesca che si è parzialmente tradotta in articoli pubblicati su riviste italiane e straniere.
1964 - con W. Boeker: Verhexungswahn, Krager, Basilea.
Si tratta di una monumentale indagine sui deliri di affatturazione degli italiani in Svizzera.
Senza data – con Giovanni Jervis, Studio sull’argismo sardo,
in: C. Gallini (a cura): I rituali dell’argia, Cedam, Padova.
1967 – Presupposti per una psicoterapia istituzionale,
in: Franco Basaglia (a cura): Che cos’è la psichiatria, Amministrazione provinciale di Parma
Ripubblicato da Einaudi, Torino 1973
1971 – Misére, Magie et Psychothérapie, in: “Confinia Psichiatrica” Vol. 14, n. 2, p. 108
Lavoro sulla comunità terapeutica magico – religiosa di Serradarce di Campagna.
1973 – Anna Bonin (a cura): Contro la fabbrica degli “emarginati”
Intervista sugli obiettivi si “Psichiatria Democratica”
Avanti 2/12/1973
1975 – Giorgio Frasca Polara: A colloquio con lo psichiatra Micelle Risso censurato dalla tv
L’esclusione del malato di mente contrabbandata come terapia.
L’unità 21/1/1975
1975 – Eleonora Puntello: Anche se sani restano nel manicomio giudiziario per ritardi delle
pratiche
L’Unità 21/1/1975
1976 – Arturo Gismondi (moderatore): “Qualcuno volò sul nido del cuculo”: una tavola
rotonda Il manicomio uccide
Paese Sera 15/4/1976
1976 – Psichiatria: non più custodia ma prevenzione
Paese Sera 17/9/1976
1978 – Enzo Rava: Quali sono le radici psicologiche della violenza?
Risponde Michele Risso
Disperati “Professionisti” di morte
Paese Sera 23/3/1978
1978 – Scavando la malattia del fratello
Paese Sera 11/4/1978
1978 – con altri: Un documento di Basaglia ed altri sulla psichiatria biologica
Malattia mentale e comportamento umano
Avanti 31/5/1978
1979 – Farfalle, uomini e topi. Cioè: a ciascuno il suo farmaco, naturalmente
il manifesto 19/9/1979
1980 – Analizzare il potere della psichiatria, la contraddizione di chi vuole operare per la
libertà reprimendo i desideri di chi cerca di soccorrere
il manifesto 23/3/1980
1980 – con Paolo Repetti: Psicoanalisi e consumo: metapsicologia e metastoria
Convengo Arci sui consumi culturali di massa, Roma 1980
in: “Giornale italiano di Psicologia”, Vol. VIII, n. 1, aprile 1981
1980 – Interviene nel “processo” uno psichiatra democratico
Invece Basaglia era proprio uno scienziato
la Repubblica 16/10/1980
1981- m. n. : Michele Risso, psichiatra. Un amico, un compagno
il manifesto, 4/6/1981
1981 – Segreteria generale Flm Bentivogli, Galli, Veronese: Lo ricordiamo
il manifesto 4/6/1981
1981 – Giancarlo Angeloni: E’ scomparso Michele Risso, protagonista del movimento
antistituzionale. - Il generoso della psichiatria
L’Unità 4/6/1981
1981 - Luigi Cancrini: Michele Risso. Ora Tutti sentiremo il peso della sua assenza. Lo
psicanalista è morto ieri a Roma dopo una grave malattia. Le sue
battaglie con Psichiatria Democratica
Paese Sera 4/6/1981
1981 – Pietro Ingrao: Cosa ci ha insegnato Michele Risso. Abbattere i muri dei silenzi, ecco il
mestiere di vivere
L’Unita 5/6/1981
1981 – A. L. : E’ morto Michele Risso, collaboratore di Basaglia per l’ “altra psichiatria”
la Repubblica 5/6/1981
1981 – Giorgio Bignami: Terapeutica e politico, psicoanalisi e antipsichiatria, Michele Risso
compagno di Basaglia nella contraddizione
il manifesto 11/6/1981
1981 – aa. vv. : Contro l’ideologia, anche quella antimanicomio. Freud Manicomio, Tecniche e
politica, Psicoanalisi post ’68, Cronificazione
il manifesto 11/6/1981
1981 – Raffaello Misiti: La psicoanalisi difficile di Michele Risso. Scompare dopo Maccacaro e
Basaglia, un’altra esistenza bruciata nella critica teorica e pratica
delle scienze dell’uomo
Rinascita n. 24 – 12/6/1981
1981 – Fabrizio D’Agostini – Il dolore e la ragione
Rinascita n. 24 – 12/6/1981
1981 – con Paolo Repetti: Cronicità e cronificazione
Sapere, agosto – settembre, pp. 53-56
1981 – Che cos’è una terapia? È difficile creare una nuova cultura psichiatrica
Paese Sera 17/10/1981
Ripubblicato in: Vincenzo Caretti, Giovanni P. Lombardo, Psicologia e psichiatria,
Bulzoni, Roma, 1981
1982 – Di sradicamento si soffre, talvolta si muore. La via della speranza è quella della
nostalgia. Emigraione e malattia mentale, scritti di Frigessi e Risso
il manifesto 23/1/1982
1982 – con Delia Castelnuovo Frigessi: A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia
mentale, Einaudi, Torino.
1992 – con Wolfang Boeker: Sortilegio e delirio. Psicopatologia dell’emigrazione in
prospettiva transulturale, Liguori, Napoli
2005 – C.I.P.E.C. Centro di iniziativa politica e culturale. Quaderno n. 30.
Luigi Pellegrino, Sergio Dalmasso, Agostino Pirella, Franca Ongaro Basaglia, Piero Ingrao, Regina Chiecchio, Gianna Tangolo.
Per ricordare Michele Risso – Atti del convegno, Boves, 1° marzo 1996
Centro Stampa della Provincia di Cuneo.
RISSO MICHELE, TIROCINIO E ATTIVISMO, in “Fogli di informazione”, n. 18-19, pp. 76-78 (1975)
Il ruolo dello psicologo, per come è concepito, non ha sbocchi ma prevede lunghi periodi di disoccupazione dopo la laurea. È da qui che bisogna partire per discutere concretamente. Il rischio dei tirocini, se non hanno spazi adeguati, è di risolversi in attivismo, l’altro rischio è quello di un tecnicismo settoriale acritico accumulato dentro la facoltà di psicologia.
MINGUZZI GIANFRANCO, MISITI RAFFAELLO, PIRELLA AGOSTINO, RISSO MICHELE, [LA] FORMAZIONE, in “Fogli di informazione”, n. 27-28, pp. 55-62 (1976)
Esaminati i limiti e le contraddizioni nel campo della formazione si constata che anziché esaudire bisogni reali si è risposto in modo frammentario e clientelare aumentando le figure professionali. È invece necessaria una rifondazione delle scienze umane che non dia per scontato che i bisogni individuali sono separati da quelli sociali e che si sappia quali sono, perché, di fatto, il bisogno appare sul mercato in forme a cui il mercato stesso può rispondere. Il passaggio da strutture chiuse a strutture aperte, attraverso la partecipazione, implica operatori profondamente diversi. Per questi è auspicabile l’operatore unico che eviti sia la sia la superspecializzazione che la genericità, in grado di dare risposte scientificamente fondate nello specifico, e di programmare trasformazioni di lungo periodo che investano il sociale.
BIGNAMI GIORGIO, RISSO MICHELE, TERZIAN HRAYR, TERZO RADUNO, TRIESTE SETTEMBRE 1977. DOCUMENTO RIASSUNTIVO DEI LAVORI DI COMMISSIONE SUI TRATTAMENTI SOMATICI IN PSICHIATRIA, in “Fogli di informazione”, n. 44, pp. 48-54 (1978)
Sostenuta la necessità di analizzare ogni tecnica nel suo contesto, si indica quella di denunciare ogni abuso, forma di controllo. Anche l’autogestione deve avere come fine la demedicalizzazione e il controllo di base per arrivare alla prevenzione. Le tecniche si impongono spesso come conferma a posteriori della loro capacità di silenziare i sintomi e disgregare psicologicamente la personalità dei pazienti. La trasmissione del potere – sapere su cui le tecniche si fondano è sempre verticale. Si rifiuta totalmente la psicochirurgia, l’elettrochoc, l’impregnazione psicofarmacologica e metadonica, la sperimentazione psicofarmacologica non partecipata. L’uso alternativo delle tecniche non deve portare alla divisione psiche – soma, mente – corpo, a forme di controllo medicalizzato. Si è discusso della possibilità di gestire la crisi psicotica senza farmaci e sulla maggior recidività delle crisi gestite con psicofarmaci. È indispensabile informare il paziente il più possibile, verificare con attenzione di non esportare sul territorio tecniche manicomiali, modificare l’informazione rendendola più oggettiva, criticare sistematicamente i modelli e le ideologie.
RISSO MICHELE, SULLA IDEOLOGIA DELLA PREVENZIONE SECONDARIA IN PSICHIATRIA, in “Fogli di informazione”, n. 50, pp. 353-355 (1978)
La malattia mentale non è definibile in termini medici se non come giudizio che giustifica la segregazione manicomiale e l’uso di terapie biologiche, che, senza alcun fondamento scientifico, destrutturano l’organizzazione psicologica dei soggetti bloccando le loro possibilità di elaborazione. Le tecniche psicoterapeutiche si muovono all’interno di un eclettismo spinto e di una trasmissione verticale del potere – sapere su cui si fonda l’intervento tecnico. Anziché affrontare l’inconsistenza epistemologica della nosografia e delle terapie psichiatriche, la psichiatria perfeziona interventi di negazione del sintomo e di normalizzazione come tecniche avanzate e trasforma una qualità che sfugge all’osservatore in quantità misurabile, attraverso la manipolazione. Prevenzione significa conoscere la qualità di ciò su cui si vuole intervenire, tenendo presente che l’intervento psichiatrico modifica lo sviluppo patogenetico delle affezioni, attraverso i messaggi e gli atteggiamenti di chi cura. Le lotte antistituzionali hanno dimostrato che il fatalismo clinico di molti psichiatri non ha ragione d’essere e che l’esito di psicosi acute trattate col minimo di intervento e col rispetto del significato di quanto sta avvenendo al paziente, è molto migliore delle tradizionali statistiche psichiatriche. La prognosi dei casi non trattati è migliore di quelli trattati. Gli interventi tecnici modificano, spesso in peggio, il progredire della patogenesi dei disturbi psichici. L’unica epidemiologia possibile riguarda l’interazione tra operatore, utente e gruppo di appartenenza, cioè l’evoluzione della domanda di assistenza in funzione della risposta dei servizi. Questo per favorire un’opera di prevenzione non medicalizzata che tenda alla indagine dei contenuti della domanda senza fissarla in schemi che intervengono sui servizi stessi.
RISSO MICHELE, PSICOTERAPIA ANALITICA E PSICOTERAPIA FAMILIARE, in “Fogli di informazione”, n. 51-52, pp. 403-405 (1978)
Risso osserva che l’utilizzo del termine schizofrenia ha caratteristiche ideologiche perché tratta il problema come si trattasse di una malattia accertata di cui si conoscono le cause, confondendo ipotesi eziologiche e fatti dimostrati. Le ipotesi psicogenetiche hanno su quelle bio – organicistiche il vantaggio di tenere aperti i problemi cercando risposte psicoterapiche anziché sedarli con i farmaci o richiudendoli in logiche di esclusione manicomiale. La psicoterapie analitiche delle psicosi per la lunghezza del trattamento, l’impegno richiesto, l’incertezza dei risultati, sono ora via via sostituite dalla terapia familiare di tipo sistemico. Essa si presenta come una pratica fondata scientificamente cosa della quale, invece, Risso dubita fortemente. Nel campo della psicoterapia delle psicosi è importante mantenere spazi di incertezza e cautela anziché lasciarsi andare a certezze acritiche.
BIGNAMI GIORGIO, RISSO MICHELE, INTRODUZIONE SUL PROBLEMA DELLE TECNICHE TERAPEUTICHE IN PSICHIATRIA, in “Fogli di informazione”, n. 57-58, pp. 302-314 (1979)
L’articolo costituisce il lavoro della commissione per le tecniche terapeutiche al Reseau di Trieste (1977). Le pratiche antistituzionali insieme alle istituzione hanno messo in questione tutta una serie di schemi scientifici, tecnici, culturali, nati da una miscela di biologismo, psicoanalisi, psicologismo. Il sociologismo trasforma il prodotto in dato e su questo costruisce i suoi modelli e le sue teorie. Essi sono poi integrati in modelli più ampi e totalizzanti che confondono qualità e quantità fino ai modelli destorificanti della devianza. Questi modelli non hanno cambiato minimamente la realtà istituzionale italiana. Criticati elettrochoc e psicochirurgia, si è discusso delle tecniche come strumento di silenziamento automatico, come forma interiorizzante di controllo tra loro intercambiabili, che hanno come base comune la destorificazione del disagio, la sua individualizzazione e localizzazione di piccolo gruppo, escludendo sempre il sociale. Analizzata la medicalizzazione della devianza nei diversi paesi, si è criticato l’uso della sedazione massiccia con psicofarmaci e si è accettato il fatto che non ci sono criteri oggettivabili “in positivo” per un uso alternativo delle tecniche ereditate dal passato. È emersa anche la nuova professionalità dell’infermiere legata alla degerarchizzazione e ai rapporti stabiliti con la popolazione, oltre alla scarsa informazione sugli psicofarmaci legata alle modalità confuse e contraddittorie con cui vengono pubblicizzati.
BIGNAMI GIORGIO, FRONTALI MARINA, GIARDINI VALERIO, RISSO MICHELE, PROPOSTE DI DISCUSSIONE SULLE TECNCIHE DI CONTROLLO E SUI LORO FONDAMENTI SCIENTIFICO – IDEOLOGICI, IN “Fogli di informazione”, n. 57-58, pp. 315-318 (1979)
Si critica l’uso indiscriminato di psicofarmaci, specie i neurolettici, con pazienti etichettati come schizofrenici, perché: 1) Esercita un controllo senza appello sulla vita del paziente; 2) Condanna alla discinesia tardiva; 3) Riconferma il modello biologico organicistico. Superando riduzionismi e con incertezze epistemologiche di vario tipo, le pratiche antistituzionali, restituendo soggettività all’utente, stanno lavorando per la rifondazione di una nuova scienza del comportamento umano di cui è necessario costituire una teoria generale attraverso i modelli parziali da estendere via via a tutti gli strumenti usati.
RISSO MICHELE, MALATTIA MENTALE E TERAPIA, in “Fogli di informazione”, n. 57-58, pp. 345-351 (1979)
La definizione di malattia mentale da un punto di vista medico non ha fondamento dimostrabile, né sul piano concettuale, né su quello operativo, e si limita a un pregiudizio proposto come giudizio medico di diversità, sancito dal ricovero manicomiale. Le terapie biologiche destrutturano l’organizzazione psicologica dei soggetti e bloccano successive possibilità di elaborazione e di sviluppo. Le psicoterapie non tengono conto del fatto che si sa ben poco della eziologia e patogenesi della malattia mentale e si muovono spesso su un eclettismo acritico. Caratteristica di tutte le tecniche è la trasmissione verticale del potere – sapere che trasforma una qualità sfuggente (il disagio psichico) in qualità misurabile attraverso la manipolazione. Per questo la prevenzione è difficile, perché gli interventi farmacologici e clinici, l’atteggiamento e i messaggi di chi cura (che spesso vede la malattia mentale come dato e non come prodotto) modificano lo sviluppo della patogenesi dei disturbi. Le terapie psichiatriche non hanno alcuna veste o dignità secondo i canoni della clinica, agendo solo come strumenti di silenziamento sintomatico. I pazienti hanno bisogno non di cure specifiche, ma di persone che prendano cura di loro.
CASTELNUOVO FRIGESSI DELIA, RISSO MICHELE, A MEZZA PARETE. EMIGRAZIONE, NOSTALGIA, MALATTIA MENTALE, Einaudi, Torino, 1982
La nostalgia come malattia: un problema che non è di pertinenza medica finisce per coinvolgere la medicina, tanto che si è cercato di dimostrare la stretta correlazione, l’interdipendenza tra emigrazione e malattia mentale. In ambedue i casi si spiega il fenomeno con analoghi meccanismi di razionalizzazione: psicologi, medici e sociologi. La qualità innegabile dello sradicamento è coperta e interpretata mediante la sua quantificazione in numeri e percentuali. Medici e psichiatri propongono sindromi e localizzazioni, limiti e paragoni tra l’emigrato e l’autoctono: quello degenerato, pre – schizoide, questo sano e normale. Si costruiscono teorie che funzionano da schermo ai problemi della miseria, della violenza sociale e del sottosviluppo mentre si propagandano teorie che rispondono all’opportunità di una nuova organizzazione e divisione del lavoro. Tuttavia le ricerche epidemiologiche e gli studi a catena sulla psicopatologia dell’emigrazione condotti fino ad oggi negli Stai Uniti ed in Europa hanno innescato un processo che contiene in sé la propria negazione. Viene occultato, più che risolto, il rapporto privilegiato tra immigrazione e malattia mentale anche quando il nesso tra predisposizione, comportamenti e tratti etnici è reputato e le ipotesi i risultati scientifici fino a quel momento dati per certi vengono corretti o addirittura rovesciati. Ed emergono così nuove domande.
Delia Frigessi Castelnuovo ha curato La cultura italiana del ‘900 attraverso le riviste: «Leonardo» «Hermes» «Il regno», 1960, Reprints 1977 e di Carlo Cattaneo, Opere scelte, 1972. Trasferitasi in Svizzera nel 1969, ha pubblicato indagini politiche e antropologiche sui lavoratori italiani emigrati (Elvezia, il tuo governo, 1977; Tendences des études sur migration et maladie mentale, Vevey 1980) e ha lavorato con le organizzazioni dell’emigrazione e con quelle elvetiche nel campo della formazione professionale e per la difesa di diritti politici e sindacali dei lavoratori all’estero.
Michele Risso è nato a Boves nel 1927, ha studiato medicina a Torino, dove si è specializzato in neurologia e psichiatria; dal 1955 al 1963 ha lavorato come psichiatria a Berna, dove ha condotto un’indagine sugli emigrati italiani ricoverati negli ospedali psichiatrici della Svizzera tedesca tra il 1946 e il 1960. Nel 1963 è tornato in Italia, stabilendosi a Roma ed è stato tra gli animatori di Psichiatria democratica. Ha collaborato a riviste italiane e internazionali di psichiatria e psicologia. Un suo contributo è compreso nel libro curato da Franco Basaglia, Che cos’è la psichiatria, Einaudi, 1973. È morto a Roma nel luglio del 1981.
Quaderni C.I.P.E.C.
n. 1, aprile 1995
Lucia Canova, donna e comunista
Il PSIUP in provincia (Sergio Dalmasso)
n. 2, ottobre 1995
Chiaffredo Rossa, scalpellino
La nuova sinistra nella provincia bianca (Sergio Dalmasso)
Bibliografa sulla sinistra cuneese (Carlo Giordano)
n. 3, novembre 1995
Maria Capello, la ragazza rossa (Cetta Berardo)
Testimonianze di Carlin Petrini e Sergio Dalmasso
Bra fra slanci rivoluzionari e reazione fascista (Livio Berardo)
n. 4, luglio 1996
Le vicende elettorali delle forze politiche cuneesi (1945/1996)
Tabelle, grafici, saggi introduttivi di Felice Paolo Maero e Sergio Dalmasso, grafici di
Marco Dalmasso
n. 5, marzo 1997
Militanti e dirigenti del PCI negli anni '50 e '60 (Pietro Panero, Mila Montalenti,
Mario Romano, Walter Botto, Leopoldo Attilio Martino).
Introduzione di Sergio Dalmasso
n. 6, maggio 1997
Lettere dal confino di Giovanni Barale (1939-1941). A cura di Luigi Dalmasso
n. 7, ottobre 1997
Per ricordare Michele Risso, Atti del convegno, Boves, 1 marzo 1996
(Luigi Pellegrino, Sergio Dalmasso, Agostino Pirella, Franca Ongaro Basaglia,
Pietro Ingrao, Gianna Tangolo, Regina Chiecchio)
n. 8, gennaio 1998
Luigi Borgna
Pietro Panero
Appunti sul PSI-PSDI (Mario Pecollo)
Lo sciopero dei Pumet: Dronero, primavera 1954 (Carlo Giordano)
n. 9, maggio 1998
Il PCI dalla "legge truffa" alla morte del "migliore" (Sergio Dalmasso)
n. 10, luglio 1998
Comunisti nel cuneese, scritti a cura di Giuseppe Biancani (1920-1981), a cura di
Luigi Bertone
n. 11, ottobre 1998
Fascismo oggi, vecchi e nuovi miti (Marco Revelli)
"Incompiuti"
n. 12, marzo 1999
I 95 anni di Lucia Canova
Oronzo Tangolo scritti
Testimonianze di Mario Di Meglio e Sergio Dalmasso
n. 13, aprile 1999
Quell'estate a Ulan Bator (Enzo Santarelli)
Maria Capello, elogio dell'eresia (Sergio Dalmasso)
Oronzo Tangolo (Roberto Baravalle)
Testimonianze sul PSIUP cuneese (Mario Pellegrino, Eraldo Zonta,
Giuseppe Costamagna)
"Incompiuti"
n. 14, maggio 1999
I colloqui di Dresda
La CGIL a Cuneo negli anni '50-'60 (Livio Berardo). Testimonianze di
Francesco Angeloni, Giuseppe Trosso, Marcello Faloppa
"Incompiuti"
n. 15, agosto 1999
1945-1958. Il caso Giolitti e la sinistra cuneese del dopoguerra (Sergio Dalmasso)
n. 16, settembre 2000
1958-1976. I rossi nella "granda". La sinistra in provincia di Cuneo (Sergio Dalmasso)
n. 17, ottobre 2000
1976-1992. Appunti sui partiti politici nel cuneese (Sergio Dalmasso)
n. 18, novembre 2000
Comunisti a Mondovì: Mario Giaccone, Concetta Giugia.
Il secondo "biennio rosso" (Sergio Dalmasso)
Il sessantotto a Cuneo (Sergio Dalmasso)
n. 19, aprile 2002
Il Novecento nella storiografia di fine secolo (Sergio Dalmasso,
Luigi Bertone, Michele Girardo)
Dino Giacosa: la coerenza (Sergio Dalmasso)
Riformismo e riforme nella sinistra italiana (Sergio Dalmasso)
I partiti socialisti, il centro- sinistra, la pianificazione nella
lettura della rivista "Questitalia" (Sergio Dalmasso)
n. 20, aprile 2002
Dalla Bolognina a Pristina: Cronologia di articoli su una resa:
29 ottobre 1998 - 29 maggio 2000 (Beppe Nicola)
Ricordi di Maria Teresa Rossi e di Franco Camicia (Sergio Dalmasso)
n. 21, maggio 2002
1958- 1976. I rossi nella "Granda". La sinistra in provincia di Cuneo
(Sergio Dalmasso): Seconda edizione con breve appendice.
n. 22, agosto 2002
La carovana di Lotta Continua e l'"eterno" problema dell'organizzazione
(Diego Giachetti)
Le sofferenze del PCI torinese negli anni dei governi di unità nazionale
(Ida Frangella e Diego Giachetti)
n. 23, novembre 2002
Le vicende elettorali delle forze politiche cuneesi (1945/2001)
Tabelle, grafici, saggi introduttivi di Felice Paolo Maero e Sergio Dalmasso
n. 24, gennaio 2003
Convegno Antisemitismo, razzismo, nuove destre (Luca Sossella, Luigi Urettini,
Sergio Dalmasso, Saverio Ferrari)
Un altro comunismo? (Sergio Dalmasso)
Unificazione europea? (Francesco Lamensa)
n. 25, febbraio 2003
Comunisti a Mondovì. In ricordo di Concetta Giugia Giaccone.
Lelio Basso nella storia del socialismo italiano (Luciano Della Mea, Rocco Cerrato, Sergio
Dalmasso, Piero Basso)
Rifondare è difficile. Rifondazione Comunista dallo scioglimento del PCI al “movimento dei
movimenti” di Sergio Dalmasso: recensioni, schede, segnalazioni.
n. 26, giugno 2003
La nuova sinistra italiana e la guerra di guerriglia durante gli anni ’60 (Aldina Trombini)
n. 27, gennaio 2004
Comunisti/e a Boves (Bartolomeo Giuliano, Edda Arniani, Carmelo Manduca, Giovanni “Spartaco”
Ghinamo) a cura di Sergio Dalmasso.
n. 28, febbraio 2004
Alberto Manna, Consigliere provinciale. Interventi al Consiglio provinciale di Cuneo (1995-1999)
n. 29, giugno 2005
Come era bella la mia Quarta (Silvio Paolicchi)
Ancora su foibe, fascismo antifascismo (Gianni Alasia)
Piccole storie dentro una grande storia (Enrico Rossi)
I miei amici cantautori (Sergio Dalmasso)
n. 30, ottobre 2005
Rifondare è difficile. Rifondazione Comunista dallo scioglimento del PCI al “movimento dei
movimenti” (Sergio Dalmasso)
n. 31 novembre 2005
Ristampa quaderno n. 7 Per ricordare Michele Risso, Atti del convegno, Boves, 1 marzo 1996 (Luigi Pellegrino, Sergio Dalmasso, Agostino Pirella, Franca Ongaro Basaglia, Pietro Ingrao, Gianna Tangolo, Regina Chiecchio)
n. 32 marzo 2006
Appunti sul Socialismo Italiano.
A cura di Sergio Dalmasso
n. 33 settembre 2006
Comunisti/e a Boves.
A cura di Sergio Dalmasso
n. 34 gennaio 2007
La Lega Nord nel Cuneese
A cura di Sergio Dalmasso
n. 35 febbraio 2007
Gianni Alasia
A cura di Sergio Dalmasso, Vittorio Rieser, Fabio Dalmasso, Claudio Vaccaneo
Ciclo: "Marxismo oggi":
- Marx oggi (Gian Mario Bravo)
- Il marxismo nella Terza Internazionale (Aldo Agosti)
- Per una ricostruzione del pensiero marxista (Costanzo Preve)
- Il proletariato in Marx (Cesare Pianciola)
- Il pensiero di Bloch (Laura Boela)
Ciclo: "Le rivoluzioni del '900":
- Rivoluzione francese (Costanzo Preve)
- Rivoluzione sovietica (Massimo Bontempelli)
- Rosa Luxemburg (Cosimo Scarinzi)
- Stalin, Trotskij, Bucharin, Togliatti (Antonio Moscato, Marco Rizzo)
- Rivoluzione cinese (Edoarda Masi)
- Rivoluzione cubana (Enrico Luzzati)
- La Palestina (Guido Valabrega)
continuazione del Ciclo:
- I paesi dell'est (Guido Valabrega)
- Il Sudafrica (Edgardo Pellegrini)
Ciclo: "Marxismo e...":
- Marxismo e femminismo (Nadia Casadei)
- Marxismo e libertà (Ludovico Geymonat)
- Marxismo e ecologia (Tiziano Bagarolo)
- Marxismo e economia (Riccardo Bellofiore)
- Marxismo e religione (Emanuele Paschetto)
- Marxismo e psiconalisi (Mario Spinella)
- Marxismo e nonviolenza (Enrico Peyretti)
Ciclo: "500 anni bastano":
- La storia della conquista (Franco Surdich)
- Il popolo Mapuche - Cile (Nelly Ayenao)
- Gli indiani del nord (Nayla Clerici)
- La Chiesa in America Latina (Giulio Girardi)
continuazione del Ciclo:
- Nord/Sud del mondo e il debito (Gerson Guymaraes)
- L'ambiente e la conferenza di Rio (Carlo Daghino)
- Proiezione video sugli incidenti razziali a Los Angeles
- Che Guevara (Gianluca Giachery e Sergio Dalmasso)
- Marxismo e nazionalità (Renato Monteleone)
- Ricordo di Ludovico Geymonat, filosofo della libertà (Fabio Minazzi)
Ciclo: "Marx oggi": - Il marxismo in Italia (Costanzo Preve)
- Il marxismo nel terzo mondo (Enrica Collotti Pischel)
- Marxismo oggi (Romano Madera)
Ciclo: "Storia della psicoanalisi"
- Freud (Alberto Camisassa)
- Jung (Giorgio Raimondi)
- Adler (Adriana Roassi Garzillo)
- Reich (Beppe Corona e Giorgina Lerda)
- Teorie freudiane e pratica terapeutica (Angelo Mondini)
- La micropsicoanalisi (Liliana Zonta)
Ciclo: "Analisi e terapie":
- Gestalt (Mario Frusi)
- Comportamentismo (Aldo Lamberto)
- Analisi sistematica (Massimo Schinco)
- Terapia del contatto (Luciano Jolly)
- Terapia del movimento (Elide Bono)
- Psicodramma (Giorgio Raimondi)
Fuori ciclo:
- La nuova sinistra: per un bilancio storico politico (Marco Revelli, Paolo Ferrero, Oscar Mazzoleni, Sergio Dalmasso)
Anno 1995-1996
Leone Trotsjij, un fantasma nella storia (Gigi Viglino)
- Storia, geografa, economia davanti ai problemi globali del mondo (Manlio Dinucci)
- Psichiatria democratica (Agostino Pirella, Paolo Henry)
- Per ricordare Michele Risso (Agostino Pirella)
- Guevara e l'America latina (Antonio Moscato) - Il caso Sofri-Calabresi, Lotta Continua (Ennio Pattoglio, Sergio Dalmasso)
- Democrazia Proletaria, "Camminare eretti" (Giannino Marzola)
- Lelio Basso nel socialismo italiano (Sergio Dalmasso)
- Storia critica della repubblica (Enzo Santarelli)
- Riviste a sinistra (Marco Scavino)
- Salute mentale e superamento dei manicomi (Agostino Pirella)
Il Che, 30 anni dopo (Antonio Moscato)
La rivoluzione Sovietica (Roberto Preve)
La globalizzazione (Franco Turigliatto, Raffaello Renzacci)
Una scelta di vita (Eugenio Melandri)
Il Perù e l'America latina (Isaac Velasco)
Il lavoro minorile (Carlo Daghino
Il caso Sofri (Fabio Levi)
Il Chiapas oggi (Luigi Urettini, Chiara Vergano)
Ciclo: "Immagini dell'uomo":
- Rapporto terapeuta/paziente
- Rapporto genitori/figli
- Rapporto uomo/donna
Kurdistan (Laura Schrader, Hasti Fatah)
La rivoluzione non violenta dei Sem Terra (Nadia Demond, Michelangelo Ramero)
Ciclo: "Quanto vuoi?":
- Prostituzione e immigrazione (Fredo Olivero)
- Aspetti antropologici della prostituzione (Giancarlo Ferrero)
- Prostituta e cliente (Franco Barbero, Carla Corso)
Ocalan libero (Laura Schrader, Hasti Fatah)
Guerra e democrazia (Raniero La Valle)
Nodi storici e religiosi nei Balcani (mons. Diego Bona, Luigi Cortesi)
"Attraverso il filo", il caso Silvia Baraldini (Maurizio Buzzini)
Ciclo: "100 anni di psicoanalisi":
- Analista - cliente
- Le età
- Psicoanalisi e sessualità
- Marxismo ed ecologia, Ecofemminismo (Tiziano Bagarolo, Antonella Visintin)
- La globalizzazione in America latina (Marina Ponti)
- Il viaggio del Che in America latina (Antonio Moscato)
- Presentazione del libro: Siamo solo noi, Vasco Rossi (Diego Giachetti)
- Quale carcere? (Beppe Manfredi, don Elvio Davoli)
- Presentazione "Rivista del Manifesto" (Giancarlo Aresta)
- Presentazione rivista "Carta" (Marco Revelli)
Convegno 1968-1969, il biennio rosso (Luigi Urettini, Sergio Dalmasso, Diego Giachetti, Carla Pagliero, Franco Bagnis, Fabio Panero, Vittorio Bellavite, Carlo Carlevaris, Mario Cordero, Roberto Niccolai, Marco Scavino, Vittorio Rieser, Carlo Marletti)
Ciclo Datemi una barca (Scuola di pace di Boves):
- Giubileo e debito internazionale (Giulio Girardi)
- Il sistema globale (Manlio Dinucci)
- Teologia della liberazione e diritti umani (Josè Ramos Regidor)
- I movimenti rivoluzionari in America latina (Antonio Moscato)
- Sinistra alternativa, plurale, sociale? (Marco Prina, Gianna Tangolo, Alfredo Salsano, Fulvio Perini)
- I rossi nella Granda (Mario Borgna, Alberto Cipellini, Sergio Dalmasso)
- Convegno: "Gli anni '70" (Marco Scavino, Sergio Dalmasso, Vittorio Bellavite, Diego Giachetti,
Diego Novelli, Mario Renosio, Carla Pagliero, Gigi Malaroda, Pina Sardella, Nicoletta Giorda)
- Convegno: "Razzismo, antisemitismo, nuova destra" (Luigi Urettini, Moni Ovadia, Saverio Ferrari, Guido Caldiron,
Remo Schellino, Mario Renosio, Sergio Dalmasso)
Ciclo Gli esclusi (Scuola di pace di Boves)
- La conquista dell'America dalla parte dei vinti (Giulio Girardi)
- Fabrizio De Andrè, cantante degli umili (Romano Giuffrida)
- I nostri amici cantautori (concerto)
- Presentazione del libro “Rifondare è difficile” di Sergio Dalmasso (Gastone Cottino)
- Convegno "Cosa resterà di questi anni '80?"
(Diego Berra, Sergio Dalmasso, Claudio Mondino, Marinella Morini, Fulvio Perini, Lucio Magri, Marco Revelli, Lidia Cirillo, Diego Giachetti, Carla Pagliero).
- La crisi argentina (Antonio Moscato)
Ciclo "Gli esclusi" (Scuola di pace di Boves)
- La canzone popolare (Fausto Amodei)
- Un altro comunismo: Leone Trotskij, Rosa Luxemburg (Antonio Moscato)
- La Palestina (esponente dell'OLP)
- Globalizzazione ed economia (Nerio Nesi)
- Sindacato e movimenti dopo Firenze (Mario Agostinelli)
Convegno "Vent'anni della Scuola di pace di Boves"
- La marcia delle donne (Nicoletta Pirotta)
- L'alternativa al liberismo e al terrorismo (Giulio Girardi)
- Vent'anni di storia, vent'anni di guerre (Luigi Cortesi)
- Ernesto Balducci, Gunther Anders e il pacifismo di oggi (Enzo Mazzi, Luigi Cortesi)
- Convegno "1945/1948: gli anni della ricostruzione" (Sergio Dalmasso, Marinella Morini, Martino Pellegrino, Laurana Lajolo, Elena Cometti, Fabio Panero, Claudio Biancani, Michele Calandri, Paolo Perlo, Carla Pagliero, Sofia Giardino)
- Ciao Raffaello, in ricordo di Raffaello Renzacci (Giorgio Cremaschi, Fulvio Perini, Franco Turigliatto, Rocco Papandrea, Sergio Dalmasso).
- Liberalismo e liberismo (Sergio Dalmasso).
- Comunismo, marxismi, democrazia (Sergio Dalmasso).
- Riccardo Lombardi, per una società diversamente ricca (Nerio Nesi, Giancarlo Boselli, Sergio Dalmasso).
- Rosa Luxemburg (Sergio Dalmasso).
- Convegno Gli anni ’60 (Daniela Bernagozzi, Carla Pagliero, Diego Giachetti, Marinella Morini, Sofia Giardino, Chiara Rota, Giuliano Martignetti).
- La stagione dei movimenti (Sergio Dalmasso).
- La questione palestinese (Cinzia Nachira)
- Film: Noi non abbiamo vinto? (Gianni Sartorio, Giampiero Leo, Sergio Dalmasso)
- 1956: l’invasione dell’Ungheria (Mario Martini, Gianni Alasia, Sergio Dalmasso)
- Comunisti/e a Boves (Nello Pacifico, Sergio Dalmasso)
- Totalitarismi e democrazia (Sergio Dalmasso)
1 da Guido Giuffré, «Guttuso Burri Vespignani Baj Gruccione Ceroli», Editore Il Grafo. Roma 1969.
1 Al di là di queste sintetiche battute introduttive si deve rinviare, per la storia della psichiatria, a trattazioni classiche come quella di M. FoucauIt (Storia della .follia nell'età classica, nuova edizione accresciuta, Rizzoli, 1976) e di K. Domer (Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria, Laterza, 1975).
2 F. Basaglia (a cura di), Che cos'è la psichiatria?, Einaudi, 1967; F. Basaglia (a cura di), L'istituzione negata, Einaudi, 1968. Per delle ricognizioni recenti su questo argomento si vedano: D. De Salvia, Per una psichiatria alternativa, Feltrinelli, 1977; A. Manacorda e V. Montella, La nuova psichiatria in Italia, FeltrineIli, 1977.
3 Si vedano, in un recente fascicolo di «Clinica psichiatrica» (rivista a cura dell'Istituto di studi psicologici e psichiatrici Villa S. Rita; Anno XV, n. 25, giugno 1979), l'articolo di C. Catalano-Nobili (Critica della nuova regolamentazione dell'assistenza psichiatrica, pp. 7-33) e quello di G. Calella (Riflessioni su alcune esperienze di psichiatria «extra» e «anti-istituziona le», pp. 35-55).
4 Si confrontino ad esempio le tesi dello psichiatra-scrittore M. Tobino («…e cala anche questa legge che afferma la follia non esistere ... Ogni età ha la sua gonna, il suo verso, il suo ballo, la sua fortuna ... », «Corriere della sera». p. 3, lO gennaio 1980) con quelle della relazione del procuratore generale P. Pascalino alla recente inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma («…Si vedono i frutti del malvezzo di operare riforme che, destinate a rimanere sulla carta per mancanza di mezzi necessari, creano a volte per lunghissimi periodi molto più danno che vantaggio», «Corriere della sera», edizione romana, p. 11, 12 gennaio 1980)
5 Questa parte è ripresa con qualche modifica dalla nostra Introduzione sul problema delle tecniche terapeutiche in psichiatria nel fascicolo di «Fogli di informazione» che raccoglie i materiali della Commissione sui trattamenti somatici in psichiatria del raduno del Réseau a Trieste, 1977 (N. 57/58. 1979).
6 Ai retroterra scientifici di questi ultimi indirizzi è dedicato il capitolo di G. Bignami e M. Frontali: Le «basi scientifiche.» del controllo del comportamento, nel volume di AA.VV.: Psicobiologia e potere. Feltrinelli. 1977 (pp. 69-94).
7 Così titola, senza virgolette, il recente servizio di «Repubblica» sulla cura dei tossicomani in Svezia (N. Aspesi: E la Svezia lancia la repressione democratica. 20 novembre 1979).
8 Ciò è quanto è avvenuto nei paesi in cui le strategie di psichiatria di settore o di Community Mental Health sono applicate da tempo, ma senza una preclusione all'impiego di un manicomio pur razionalizzato come quella prevista dalla legge 180 (v. Francia. Gran Bretagna. Stati Uniti. Svizzera. Svezia. ecc.).
9 Si vedano in particolare J.W. Perry: La psicosi come stato visionario, «Rivista di Psicologia analitica», N. 17, pp. 213-221,1978; L.R. Mosher: Soteria's model of madness: Implication for treatment (ciclostilato del National Institute of Mental Health, Rockville, Md., USA, 1977); M. Rapoport et al.: Are there schizophrenics for whom drugs may be unnecessary or contraindicated?, «International pharmacopsychiatry», vol. 13, pp. 100-111. 1978
1 La cultura del '68 ha sicuramente espresso, soprattutto all'inizio, una serie di istanze positive, di critica reale, al sistema dominante. (Si pensi soltanto all'immagine che, prima del '68, c'era dell'autorità, delle istituzioni, del potere). Da cultura di opposizione, tuttavia, essa si è andata col tempo trasformando in cultura alternativa, ritagliandosi un suo spazio autonomo, una specie di oasi. O, se si vuole, di riserva indiana nella quale vivere, più spesso fantasticare, la propria estraneità al sistema.
Estraneità molto spesso indotta da un'industria culturale tutt’altro che restia ad alimentare i processi di mitizzazione del reale, tipici di questi ultimi anni.
Si pensi, per fare qualche esempio, alla diffusione dei testi dell'antipsichiatria inglese che parlano della esperienza schizofrenica come del momento più alto della conoscenza; oppure della «cultura psichedelica» di importazione americana e a tutte quelle forme esotiche di esperienza per le quali la realtà è un velo ostinato che si frappone fra noi e la coscienza di una verità vista sempre come unica, totalizzante, fuori dalle contingenze e dalla precarietà storiche. Pensiamo, infine, alle possibili letture di un libro come «L'Antiedipo» di Deleuze e Guattari, in cui il linguaggio, il pensiero logico di stampo classico, vengono considerati come manipolazione e ostacolo; ed a cui si contrappone la spontaneità distruttrice e creativa del Desiderio, dello scherno, della risata. Per alcuni il passo da queste posizioni ad un vero e proprio nichilismo è stato breve.
2 Il termine «sviluppo» è qui usato in contrapposizione a quello di «progresso» secondo la distinzione indicata da P.P.Pasolini.
3 Alcuni accenni: sappiamo che le Società di psicanalisi richiedono un training, lungo, pesante, costoso: sappiamo d'altra parte che, al di fuori delle Società, molti diventano analisti auto-nominandosi tali e si apprestano senza essere preparati ad un lavoro pericoloso per i loro pazienti e per loro stessi. È evidente, d'altra parte, che il problema non si risolve certo limitando la pratica della psicoterapia ai medici e agli specialisti in psichiatria che ricevono, nella loro formazione specifica, ben poco che li avvicini alla psicanalisi. Sull'altro versante ci sono migliaia di psicologi che posseggono, salvo eccezioni, sulla base di un retroterra culturale talvolta carente, una preparazione piuttosto sommaria per quanto riguarda la psicoterapia in genere e la psicanalisi in particolare.
Il problema rischia di essere "risolto" con manovre corporative e di potere, come sempre. Una possibile soluzione -strettamente legata alla riforma della scuola, dell'Università. dei corsi di Laurea - appare difficile e lontana.
1 Ci siamo serviti qui della stessa citazione che Franca e Franco Basaglia (1979) hanno scelto per introdurre il loro saggio sulla voce «Follia/Delirio» per l'enciclopedia Einaudi. In effetti, nel linguaggio che la ragione, attraverso la psichiatria, ha imposto alla follia, «l'ostinazione» del delirio, non ha avuto che un nome: cronicità.
2 Oggi il cronico di ieri è definito lungodegente. L'accento è posto non sull'aspetto «medico» della cronicità, ma su quello sociale. E tuttavia il nostro sapere non si è certo arricchito per il cambio di definizione. Né il nostro operare è di molto cambiato: nella maggior parte dei casi il malato riceve le stesse attenzioni - le stesse disattenzioni - che riceveva precedentemente; e così le stesse cure - e le stesse trascuratezze.
3 Trad. it.: Sarà pazzo colui che nell'età e nel tempo dovuto, e per sé abbia una impotenza nell'uso dell'intelletto non momentanea e fugace, ma confinata.
4 Scapini A., La pazzia nell'interpretazione di Vincenzo Chiarugi (1759-1820), Giardin, Pisa, pagg. 56-60 e segg.
5 Foucault M., «La casa della follia», in Crimini di pace, Einaudi, Torino 1975, pag.l57 (a cura di Franco Basaglia e Franca Basaglia Ongaro).
6 Vedi G. De Leo, A. Salvini, Normalità e devianza, Mazzotta, Milano 1975, pag. 58.
7 Cfr. Giovanni Jervis, Psichiatria e scienza sociale in «Crisi della medicina », Roma 1974.
8 Sulla storia del pensiero di Kraepelin, vedi Zilboorg. G. e Henry, Storia della psichiatria, Feltrinelli, Milano 1973, pagg. 399-411.
9 Bleuler E., Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Franz Deulicke, Leipzig und Wien, 1911, pag. 1.
10 Bleuler E., cit. pag. 210.
11 Freud, 5, Opere, 1912-1914, vol. 7°, Boringhieri. Torino 1975. pag. 444.
12 Bleuler. E., «Lehrbuch der Psychiatrie » Neunte Auflage von Manfred Bleuler, Springer Ver1ag, Berlin, Gottingen,
Heidelberg, 1955, pag. 329.
13 Jaspers K., «Allgemeine Psychopathologie», Sechste Auflage, Springer Verlag, Berlin, Gottingen, Heidelberg
1953, pag. 379.
14 Jaspers K., cit., pag. 333.